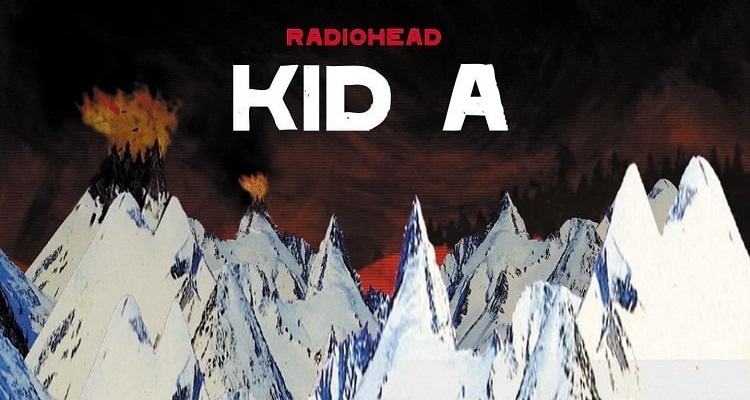
“Ma, veramente, che volete per essere riusciti a sembrare Aphex Twin del 1993, una medaglia?” – (Select Magazine)
L’anno era il 1998, e i Radiohead erano i reucci del rock. Alternativo, non alternativo fregacazzi: “Ok Computer” ha riscosso non solo uno straordinario successo di pubblico, ma un successo di critica che non si vedeva, così unanime, forse dai tempi dei Beatles. “Ok Computer”, ovverosia il più grande disco degli anni ’90. Beh, certo, anche “Nevermind” però… beh, chisselincula Kurt Cobain, non si doveva sparare, non si doveva sfondare di eroina, non si doveva maciullare il cranio. I Novanta sono il regno del sarcasmo, dei sorrisi sardonici, di quelli che diverranno cinici nel 2000; ergo che si fotta Cobain, noi andiamo avanti. Ma dice che l’ha ammazzato quella là, ma io mica ci credo, però… magari stava male, ecco. Ma magari ‘sti cazzi, non ce lo metti? Il miglior disco del decennio, anzi, del mondo, anzi dell’universo. È questo che è “Ok Computer”, e “Paranoid Android” è la nuova “Bohemian Rhapsody”, la piccola sinfonia elettrica, sommersa di chitarre. Facci vedere il piffero Thom, voglio un capezzolo di Jon, datemi una scarpa di Colin.
“What is the stupidest question a journalist ever asked you during an interview?” – (Meeting People Is Easy)
“Non c’è niente di più noioso di una rock’n’roll star (…), uno che è stato sulla strada per dieci anni, che si aspetta attenzione ovunque vada, che si instupidisce bevendo, che è sgradevole, incoerente, privo di creatività e ha un ego enorme. Non c’è niente di più inutile”, sentenzia Yorke all’uscita di Kid A. Del resto, questa sua opinione quasi snob l’aveva sempre usata come manifesto, a partire da quella “Anyone Can Play Guitar” con la quale nel 1993, l’anno di “Creep”, dell’esordio, del primo degli infiniti fraintendimenti, ironicamente delirava “Grow my hair, I am Jim Morrison” (”Fat, ugly, dead”, aveva spiegato a MTV, quando ancora si degnava di passare musica). L’insostenibile quantità di titoloni, i paragoni con i Pink Floyd, l’insipida e devastante routine dei consueti dodici mesi di tour necessari a promuovere l’album (prima “The Bends”, poi “Ok Computer”), avevano steso la band e Yorke in primo luogo, molto vicino all’esaurimento nervoso. “Ero un totale, fottuto casino”, dichiara Yorke, bruciato vivo dall’attesa, un’attesa che sarebbe irripetibile oggi, oggi che la musica è un irrilevante contorno per l’incredibile sequela di puttanate che “l’artista” mainstream si sente in dovere di inanellare, oggi che l’overflow di stimoli ha creato una mannara di zombie con la soglia d’attenzione di un pesce rosso; le uniche attese spasmodiche sono quelle che precedono i ritorni di star del passato da lungo tempo in silenzio. Forse Kendrick Lamar, ma no, non è lo stesso.
“Ok Computer” è stato, ed è tuttora, un album amato spropositatamente dalla critica, sia quella di nicchia, quella snob e concentrata sull’arte, sul significato, sulla rilevanza futura più che su quella presente, sia da quella caciarona dei titoloni iperbolici. Ma non solo: “Ok Computer” è stato un album amato dal pubblico. Il pubblico random, ipnotizzato dai video su MTV e dai ripetuti passaggi in radio, il pubblico cosciente della differenza tra musica e spazzatura in heavy rotation, in grado di distinguere l’una dall’altra anche quando l’una è l’altra, e, in parte, il pubblico elitista, quello che si è risibilmente trasformato in hipster e amante dell’indie rock, quello che un artista è un artista se non se l’incula nessuno (ma segue “artisti” che hanno un seguito di massa tra gli hipster – non colgono l’ironia del fatto che una massa differente è pur sempre una massa, ma il discorso è estremamente più complicato e arduo da esplicare in una misera parentesi).
Il nuovo millennio, in gran parte a causa della diversa fruizione della musica, non consentirà mai (o meglio, non ha sinora mai visto le condizioni affinché sia consentito) che l’attenzione sia focalizzata in maniera così unanime su una band. Adesso il pubblico è troppo nettamente diviso per condividere un’attesa. C’è chi attende Rihanna e chi attende gli Arcade Fire e, infine, chi si dedica alle sue band di culto, ai suoi Motorpsycho e ai suoi Melvins; le tre categorie non si intersecano quasi mai: chi attende uno non attende l’altra, con qualche eccezione per le ultime due categorie, eccezione tuttavia non perfetta – chi trepida per l’uno attende con moderato interesse l’altro, e viceversa. La critica, invece, è troppo impegnata a inventare gli estemporanei deliri che creino i nuovi “idoli indie del momento” per attendere qualcosa, e la critica di nicchia e quella dei titoloni hanno fatto inaspettatamente all’amore nei verdi prati digitali del web, figliando questa specie di abominio che mostruoso si aggira per l’internet, con un sorriso scheggiato e inquietante, affetto dal più preoccupante caso di disturbo dell’attenzione che si riesca a ricordare, al pari della nuova generazione di ascoltatori, mentre le vecchie generazioni di ascoltatori ti attaccano il pippone con qualunque merdone faccia musica retro.

E così è arduo descrivere a chi non l’ha provata quella spasmodica attesa, quel vociferare sempre più incessante… e mentre si attendeva, c’era chi provava a capitalizzare questa attesa in termini monetari: l’infinita pletora di imitatori rampanti trova i suoi più fieri rappresentanti nei Muse e nei Travis (e, in minima parte, nei Coldplay, che cercano la propria strada nel pop da classifica con alterne fortune qualitative, più influenzati che imitatori), che provano a replicare i successi degli oxfordiani non senza qualche successo – l’ottimo “The Man Who”, successo del 1999 per i Travis, e l’esordio, “Showbiz”, dei Muse, insulsa seppur gradevole uscita anch’essa del 1999.
Ma questi capofila (e, molto peggio, le decine e decine di band portate sulla copertina di NME come nuovi Radiohead e scomparse poco dopo), uniti all’attenzione morbosa della stampa, portano Thom Yorke ad un grave periodo di crisi artistica, e una particolare disaffezione non solo per il rock chitarristico ma per l’intera mitologia del rock’n’roll e dei suoi cliché. Strano pensare che un album di successo, da qualunque punto di vista, come “Ok Computer” possa aver causato un tale uragano distruttivo nella mente dei suoi autori: fanculo le chitarre, fanculo la melodia, fanculo il frontman con la voce mixata molto sopra gli strumenti: la voce è uno strumento, il ritmo è la nuova chiave e invece delle chitarre gli strumenti principali saranno sintetizzatori e ogni genere di cazzata che non sia una chitarra. La stessa categoria di incapaci che parlava di “In Utero” come di un disco inascoltabile è pronta a sbroccare male al risultato; eppure parliamo di un disco relativamente convenzionale, come sostiene anche il chitarrista della band Jonny Greenwood:
“Quando sono uscite le recensioni per Kid A e ci accusavano di essere stati volontariamente difficili, io pensavo ‘se ciò fosse stato vero, avremmo fatto un lavoro assai migliore per esserlo. Non è così impegnativo, tutti i pezzi durano sempre quattro minuti, è melodioso’”
Certo, è chiaramente “diverso” rispetto al canone ma, Dio santo, mica si può ripetere la stessa merda all’infinito, no? Al di là della mera difficoltà di ripetere un disco di estremo successo, un artista che si rispetti sente sempre la necessità di muoversi in direzioni diverse: Everything In Its Right Place gioca con la voce di Yorke, la distorce, la immerge nel suono e si fa guidare da una tastiera invece che da un riff di chitarra; in Idioteque ci sono una drum machine e un campionamento di un’opera di Paul Lansky; in The National Anthem un riff di basso e dei fiati. Insomma, non mi sembra si stia parlando di John Cage, diamine. Semplicemente, non avevano voglia di diventare banali, né di ripetere se stessi. Ma questo, evidentemente, per alcuni fu un vero schiaffo:
“Thom Yorke rifiuta l’idea che il disco sia stato pensato per essere ‘impegnativo’, ma non ha spiegato perché suoni come una colonna sonora composta per una compagnia di ballo sperimentale” – (The Guardian)
“È talmente sconvolgente l’evento dei Radiohead che si degnano di registrare un po’ di musica che le copie per i recensori sono distribuite su ‘pennette per l’ascolto’ incopiabili, non-scaricabili per prevenire che questa musica straordinariamente mercuriale finisca nelle mani sbagliate, e quindi schiaffata su www.violazionidicopyrightagogo.com e mostrata al grande pubblico per la grassa, pomposa, autocompiaciuta, guarda-ma-mi-so-succhiare-il-cazzo-da-solo piagnucolosa vecchia merda che è” – (Melody Maker)
“E sta per Eno. Se la gente volesse comprare i dischi di Brian Eno, comprerebbe i dischi di Brian Eno. Per inciso, vorremo brevettare la nostra invenzione del nuovo genere figo: Enocore. È tipo, ambient punk con testi molto, molto sensibili. Kid A quasi – quasi! – ci rientra, ma non sembrano esserci parole di cui parlare. Ah già, le parole sono fasciste” – (“Well Hung At Dawn: ‘Kid A’ To Zzzzz – A Radiohead Reaction-Ary”, rubrica mensile di rollingstone.com)
Queste sono alcune delle stroncature del disco, dalle quali uno potrebbe dedurre chissà quale arzigogolato affronto alla musica popolare, quale sfregio alle preziose e delicate orecchie dell’ascoltatore, mentre in realtà troviamo pezzi relativamente convenzionali, orecchiabili e scritti in maniera eccellente – semplicemente arrangiati con strumentazione meno convenzionale del solito, con qualche occasionale ritmo dispari, con un minimo di ardire, di voler andare avanti utilizzando anche influenze differenti (i dischi della Warp, Mingus e Ornette, il kraut rock), integrandole nella composizione per fare qualcosa di meno banale della mera copia carbone del disco precedente. Hornby, che ha frainteso il suo aver scritto un bel romanzo che parla di amore e dischi col capire qualcosa di musica, dall’alto della sua colonna settimanale sul New Yorker sproloquia sul disco, definendolo un disco per sedicenni, dato che chi ha uno stipendio non può mettersi ad ascoltare musica così impegnativa, un ragionamento talmente reazionario e risibile che in tanti la derisero per la stupidaggine che era. Ma queste opinioni, divertenti nel loro conservatorismo paleolitico, impallidiscono al confronto con il capolavoro della risata che è la recensione di Brett DiCrescenzo, un’imbarazzante mostruosità di 1200 parole che regala perle come:
“L’esperienza e le emozioni collegate all’ascoltare Kid A sono paragonabili all’assistere alla nascita di una bimba morta in utero mentre simultaneamente si ha l’opportunità di vederla giocare nell’aldilà su Imax”
“Il primitivo, minaccioso attacco di chitarra di Optimistic picchia come tirannosauri che si accoppiano”
“Le lampade color caramello lungo le pareti della stretta piazza della città sanguinarono verso l’alto nel cielo cobalto, che sembrava incredibilmente artificiale e perfetto come il berretto di un mago”
Ora, la recensione era (e rimane) un qualcosa di indefinibilmente “cringe”. Ma mentre la critica “convenzionale” ci andava relativamente piano coi giudizi iniziali, valutando l’album (quando non lo stroncavano, come visto sopra) come un buon esperimento, un breve detour rispetto al rock chitarristico del capolavoro precedente al quale si sarebbe presto ritornati, DiCrescenzo assaltava coraggiosamente la diligenza, dava un dieci tondo tondo e non si vergognava di sbrodolarsi; essendo i Radiohead una band i cui fan inondavano il web di community, siti, forum e quant’altro (non è un caso se il disco fu distribuito illegalmente su Napster tre settimane prima dell’uscita, e se la campagna promozionale fu largamente incentrata sull’allora quasi sconosciuto concetto di streaming, sul diario online del batterista Ed O’Brien e su brevi video online definiti “blips”), e quindi Ryan Schreiber, fondatore del sito, aveva pensato di avvisare preventivamente i siti di fan dei Radiohead della recensione, e aveva anticipato la sua pubblicazione – avvenuta in contemporanea con l’uscita del disco, cosa più o meno senza precedenti per la critica musicale costretta a sopportare i tempi tecnici di stampa – con articoli e news costanti sul disco della band inglese.
Ma i Radiohead non erano una piccola band di nicchia, ma una delle band migliori al mondo, e Pitchfork, in quel momento e in quel modo, si era piazzata dalla parte giusta della storia, mettendo le basi per diventare un riferimento nella critica musicale assai più di quanto Rolling Stone, NME e tutta la vecchia guardia saranno mai da allora in poi – Billboard ha dedicato un articolo assai interessante a quel momento catalizzatore: “Everything In Its Right Place: How A Perfect 10.0 Review Of Radiohead’s ‘Kid A’ Changed Music Criticism 20 Years Ago”. “Kid A”, nonostante inizialmente lento nelle vendite, incomincia a vendere e arriva in testa alla classifica di Billboard – prima volta assoluta per la band oxfordiana. Non solo: la sua straordinaria qualità (perché, se non fosse chiaro, il disco è effettivamente un capolavoro) ha costretto la critica a raddrizzare il tiro non solo nel lungo periodo, inserendolo nelle classifiche dei migliori dischi del decennio e di sempre, ma anche nel breve: il Melody Maker e Rolling Stone lo inseriscono nelle classifiche di fine anno, e man mano che nei mesi si consolida la reputazione dell’album e gli ascoltatori si rendono conto che, nonostante le ciarle lette da più parti, l’album è tutto tranne che “Metal Machine Music”.
Semplicemente, i Radiohead non sono stati al gioco; non solo, dimostrano ai propri pari che non è necessario spararsi un colpo di fucile in faccia (eh, ho capito, mica è colpa mia se è stato pure quello un momento chiave della musica anni ’90) per non stare al gioco: basta fare effettivamente quello che si vuole fare, senza preoccuparsi dei fan, di chi ti paga, di chi scrive sui giornali. Se il lavoro è valido, tutti questi problemi si risolvono da soli, e se perdi fan non erano fan a cui avresti dovuto interessarti già dal principio. “Kid A”, a distanza di vent’anni, mantiene la sua carica sovversiva da un lato, ma dall’altro non ha perso nulla in termini di memorabilità delle canzoni; il disco del decennio, in tanti sensi, non ultimo nel senso di voler dare una direzione differente al rock mainstream, una via possibile a un genere che aveva esaurito carica vitale, che non parlava più ai suoni destinatari naturali, ma solo a dei vecchi scassacazzo che incendiari non erano mai stati e fieri tanto meno, ma ora, da pompieri, ti propinano gli U2 di “Beautiful Day”, spazzatura retriva uscita fuori dalla ritirata con la coda fra le gambe dopo il flop di “Pop”.
E sicuramente ha contribuito alla sua longevità la moltitudine di strumenti e rielaborazioni dei suoni che, per espressa volontà della band, è stata perseguita in una maniera rigorosamente riproducibile dal vivo; ciò significa che in questi vent’anni, in ogni live, le canzoni hanno continuato a dare linfa vitale a quella idea diversa di rock, a-mitologica, scevra di glamour e pose, onesta, sincera e moderna senza essere modernista e autoreferenziale. Quella direzione per il mainstream rock si è spenta lì, dato che il talento compositivo non cresce sugli alberi e il garage rock revival – un’idea molto più semplice, comoda e vendibile, ricca di stile estetico e bohémien, è dietro l’angolo, ma la considerazione per il lavoro dei Radiohead, quella sì, da questo punto in poi avrà un risalto diverso nella storia del rock. E quella rottura, quella discontinuità con le fallimentari politiche dell’industria discografica, senza tuttavia ritirarsi nell’oscurità (“I always wanted whatever I did to end up in the high street”, sottolinea Yorke a Lauren Zoric del Guardian in un’intervista memorabile), avrà effetti proficui e duraturi.




