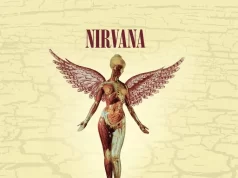Qual è il disco che ti ha cambiato la vita? Le risposte sono sempre, più o meno, romanticamente connesse all’onestà intellettuale dell’intervistato. C’è chi eccede in boria. Chi in sarcasmo. Chi è sincero. Nel mio caso, se qualche amico avesse lo sghiribizzo di domandarlo, affermerei che non si tratta di un disco, ma di una band. Che avevo tredici anni. Era il 2002. Avevo preso l’agognato possesso dell’unica televisione propriamente funzionante in casa dei miei nonni, per una serie di fortunate combinazioni (l’assenza di mia sorella, sovrana tiranna della fascia pomeridiana, più il prolungato riposo post pranzo dei restanti). Guardavo MTV a molto meno di un metro dallo schermo per tenere il volume basso. Ed era il giorno della release di “You Know You’re Right”.
All’epoca, naturalmente, non avevo idea di chi fossero i Nirvana. La cosa più giusta da fare mi sembrò acquistare quanto prima quell’album dalla copertina nera – un greatest hits, mi disse il rivenditore – e divorarlo con lo sguardo perso di un bambino che osserva un gioco di magia per la prima volta. Per giorni – forse settimane – addirittura credetti che quel gruppo fosse ancora in piedi, che prima o poi ne avrei goduto in concerto, che avrei urlato nello stesso istante in cui urlava Kurt Cobain, davanti ai miei occhi. Di lì a pochissimo, in casa, arrivò il 56K. Da quel momento, io come milioni di altr’io, avrei cominciato a invecchiare accanto al mio eroe; che sarebbe invece rimasto, come giustamente cantava il poeta, sempre giovane e bello.
Il passo immediatamente successivo, accantonati ormai gli studi e la PlayStation, fu l’appropriazione di Nevermind e insieme tutta la discografia del trio – che evaporò una serie di paghette faticosamente accumulate sfruttando ogni tipo di scusa o festività. Seguì la rinuncia a una regolare visita dal barbiere (il quale arrivò a chiedere timidamente a mio padre se mi fosse accaduto qualcosa). Una provvigione di camicie di flanella prese in blocco all’Upim (quelle che costavano meno): non propriamente il capo più funzionale alle temperature in Sicilia. Lo smembramento di (quasi) tutti i miei jeans fino ad allora integri e ora stracciati, sulle ginocchia e sugli orli. L’indossamento intensivo delle classiche Converse All Star, segretamente affondate nella fanghiglia e sottoposte a un trattamento in stile Full Metal Jacket. Lo stordimento, consequenziale, dei miei parenti. L’adolescenza arriva sempre come un ariete che sfonda la porta di una palafitta.
Se siete arrivati a questo punto, il redattore, adesso, spenderà qualche parola meno faceta sull’opera. Il riff di Smells Like Teen Spirit, uno dei più noti e suonati della storia, è il kick-offdi un intero decennio, come il suo iconico refrain sorretto dai ritmi brutali dettati da Dave Grohl e il basso insieme amalgamatore, metronomo e amplificatore di Krist Novoselic. A seguire, senza tempo per rifiatare, In Bloom. Un’altra mina meno serrata della precedente, segnata da una versione un po’ crooner di Cobain che poi esplode nel solito ritornello. Se Come As You Are serve in un certo senso da prima decelerazione – a dispetto dell’incedere della seconda metà – Breed è una delle tracce più frenetiche e primordiali del lotto, insieme alle splendide Territorial Pissings e Stay Away. Lithium e Polly, non a caso al centro della produzione, sono invece il momento più compattamente melanconico oltre la conclusiva Something In The Way. Drain You, Lounge Act e On A Plain tre ballate per cuori elettrici che mettono magnificamente in mostra le doti autoriali di un ragazzo di appena 24 anni. Si chiude definitivamente, dopo una decina di minuti di silenzio, con la folle Endless, Nameless: post hardcore viscerale e specchio assoluto del coraggio di una compagine sempre stata lontana, lontanissima dal compiacimento – per sé stessa e per l’ascoltatore.
La storia che avete letto, la mia, è una storia inopinatamente banale. Ed è banale perché accomuna milioni di ragazzi e ragazze, attraverso differenti generazioni, che per mezzo di ciò che il grungerappresentò credettero – quantomeno – di appartenere a qualcosa. Perché il grungefu, quantomeno, qualcosa. Non soltanto una fucina di talenti e dunque biechi imitatori globali, ma l’ultimo fenomeno socioculturale di massa così furiosamente vincolato a una musica dominata dalle chitarre. Per alcuni una trappola nostalgica, una madeleine. Per altri un punto di avvio, una sterzata. Per pochi invece una fine; senza che fosse un fine. Quando premetti playper la prima volta, Kurt Cobain aveva quasi il doppio esatto dei miei anni. Era il mio eroe, giovane e bello. Ed era un adulto. Nel trentennale di “Nevermind”, oggi, sono più vecchio io di cinque inverni. Non vedo più il mio eroe nelle fotografie; vedo un amico. Sommerso dal peso di un mondo che lo aveva irriso – e testé citava i suoi brani a memoria. Dalla responsabilità di rappresentare un modello. Dalla novità di essere un padre. Dalla paura di non voler diventare né santo, né diavolo, né Cristo, né Pilato. Che effetto fa vedere la tua faccia sulle t-shirt indossate dalla gente? Senza capire perché ti adorano. Vedendoti ogni giorno più imperfetto e facendo dunque il possibile per affrontarli, ancora, e non pensarci, ancora – ed affrontarti; ancora.
È il 2021 e ho sempre i capelli lunghi, Kurt. Un paio di camicie di flanella. Forse un paio di jeans strappati, che non indosso. E ho ancora tutti i tuoi dischi nella camera da letto della mia adolescenza. Se il me attuale potesse conoscere il te di allora, non ti chiederebbe una posa o una firma. Non so se avrebbe il coraggio di abbracciarti. Ma avrebbe il coraggio di dire: puoi fermarti. Se vuoi scendere, puoi scendere; puoi fermarti. C’è un cammino in mezzo, tra bruciare in fretta e spegnersi lentamente. Io lo so perché sono cresciuto sotto un vulcano attivo. Puoi far finta di dormire, anche a lungo. E ribollire, ribollire, ribollire. “You could’ve found it hard, could’ve been hard to find.Oh well, whatever. Nevermind”.