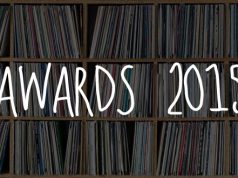Luglio 2010: I genovesi Port-Royal, con all’attivo tre album e una manciata di collaborazioni di lusso, sono riusciti in ciò cui non riesce la maggioranza delle band italiane: avere successo fuori dai nostri confini. Merito delle label per cui hanno inciso, ma anche e soprattutto di un’indole assolutamente internazionale. Musica per il cuore prima che per le orecchie, la loro. Fatta di sensazioni, paesaggi dipinti a colpi di beat e nessun compromesso artistico. Tra i più interessanti progetti indipendenti nati in Italia da tanto tempo a questa parte, i Port-Royal si sono esibiti al Barbarabeach di Catania lo scorso 18 giugno. In quell’occasione, Il Cibicida ha chiacchierato un po’ con Attilio Bruzzone, fondatore e fulcro della band.
Domanda: L’uso del pc, oggi, è sempre più in primo piano nella vostra musica. Evoluzione fisiologica?
Attilio: Probabilmente sì. “Flares”, il nostro primo album, conteneva, in effetti, ancora importanti riferimenti alla scena “post-rock” (sebbene per noi si debba parlare di un “post-rock” piuttosto atipico, una sorta di post-rock di tipo ambientale/shoegaze contaminato da parecchi elementi elettronici; quindi di qualcosa di sostanzialmente diverso da quello che di solito è inteso con questo termine): c’erano tante chitarre, importanti – seppure limitatissimi – frangenti con batteria vera e pianoforti melodici in primo piano. Ma, quasi, si trattò, potremmo dire, di un nostro “ultimo” omaggio a un universo che già all’epoca non sentivamo più del tutto nostro: i nostri gusti già da lungo tempo si erano orientati più verso i territori dell’elettronica e le classiche dinamiche post-rock mai ci sono veramente piaciute. A partire dunque dal disco successivo, “Afraid To Dance”, venne naturale incrementare l’utilizzo delle tastiere (il che comportò anche un ripensamento del modo di scrivere i pezzi) e delle basi ritmiche “artificiali” (d’altra parte da sempre utilizzate dai port-royal: basta ascoltare il nostro primo ep, “Kraken”, o pezzi come “Karola Bloch”, “Zobione pt. 3”, “Spetsnaz/Paul Leni”, tratti da “Flares”). Ci teniamo a sottolineare, però, come in tutti questi anni abbiamo mantenuto un approccio compositivo e di registrazione fondamentalmente unitario.

Domanda: Le parti vocali, inoltre, sono pian piano aumentate. Che uso fate dello strumento voce?
Attilio: Sì, in “Dying In Time” ne abbiamo fatto, per la prima volta, un uso quasi “sistematico”. D’altro canto va anche detto che noi intendiamo e trattiamo la parte vocale prevalentemente come un ulteriore strumento che vada ad arricchire la gamma dei timbri e delle melodie presenti nel pezzo, e mai quale protagonista assoluto o elemento in primo piano. Il caso dei sospiri eterei della nostra collaboratrice giapponese Izumi Suzuki aka Linda Bjalla, ospitata in più pezzi nell’ultimo disco, rende perfettamente l’idea (ma anche i nostri stessi cantati, già presenti in sottofondo sin da “Flares”). L’unico caso in cui della voce abbiamo fatto un uso più tradizionale è probabilmente quello di “The Photoshopped Prince”, che è a tutti gli effetti un pezzo di pop “intelligente”, se così si può dire. Si è trattato di uno sfizio che volevamo toglierci, un esperimento interessante reso possibile anche grazie alla collaborazione col cantante polacco Michal Wiraszko.
Domanda: Le “etichette” sono indigeste agli artisti, si sa. Ma se doveste sceglierne una fra elettronica, shoegaze e post-rock, quale sentireste più appropriata?
Attilio: Indigeste perché spesso non vogliono più dire nulla e si trasformano in paraorecchi, che invece di fornire un’utile guida all’ascoltatore, non fanno altro che precludergli una profonda esperienza della musica in questione (ovviamente, questo vale per l’ascoltatore superficiale, che, purtroppo, è un tipo in costante aumento, con cui bisogna fare i conti). Comunque, se proprio dobbiamo rispondere, sceglieremmo quella di elettronica. Un’elettronica più umana, suonata (per davvero) con sensibilità shoegaze, dance, post e ambientale.
Domanda: Uno degli aspetti più importanti è per voi l’accostamento suono/immagini. Vengono fuori in parallelo o uno dei due precede sempre l’altro?
Attilio: In verità il progetto port-royal nasce e resta un progetto fondamentalmente musicale, cui è venuto naturale – soprattutto per l’attività concertistica di stampo elettronico – accostare un lavoro visuale grazie anche alla collaborazione con Sieva Diamantakos, che ormai da anni è parte integrante del gruppo. Il suo lavoro è indipendente dal nostro (sebbene evidentemente alla base ci sia una condivisione di sensibilità e di idee, e non manchino certo discussioni sulle linee generali del progetto o nostri consigli “non vincolanti” sul suo lavoro). I suoi video e i suoi interventi live nascono comunque dopo la musica, che rimane l’elemento fondante; Sieva si lascia guidare dalle sensazioni che le nostre atmosfere gli suggeriscono per poi creare immagini che, alla fine, vivono forse di vita propria e rappresentano solo una possibile, personale, chiave di lettura e di significato.
Domanda: Il lavoro in studio presta un orecchio a quella che sarà poi la resa dal vivo dei brani?
Attilio: Assolutamente no, ne è del tutto indipendente. La questione della resa live e del modo migliore di presentare in concerto il nostro materiale nasce solo in un secondo momento. Scegliamo, per le scalette, solo quei pezzi che possono rendere al meglio dal vivo e quindi li rielaboriamo ad hoc, magari aggiungendo parti o togliendone altre, comunque riarrangiando in generale il pezzo, con l’obbiettivo, di solito, di evidenziarne al massimo la componete più potente e “danzereccia”.
Domanda: La dimensione internazionale di una band come la vostra è conseguenza della musica proposta o dipende da scelte estranee alla musica stessa?
Attilio: Indubbiamente dipende in primis dal tipo di proposta: musica strumentale, non connotata quindi da cantati e testi in lingua (quindi sganciata da ogni tipo di riferimento nazionale e/o particolare), ma con radici internazionali nei generi di riferimento, etc. Però questa è solo una faccia della medaglia; infatti, allo stesso tempo, è stata determinante la nostra volontà. Sin dai primissimi inizi, intendevamo confrontarci con la scena mondiale, con gli artisti che, in effetti, abbiamo sempre ascoltato, e non rimanere limitati a dinamiche “casalinghe” (leggasi italiane), a dire il vero un po’ asfittiche, anche in termini più concreti di visibilità e credibilità della proposta. Del resto noi spedimmo il nostro primo demo solo ad etichette internazionali (europee in particolare); scelta che fu premiata.
Domanda: In quale paese straniero avete ricevuto i feedback più positivi?
Attilio: Sicuramente, considerando anche il fatto che si tratta di zone solitamente estranee a certe dinamiche (ma il trend per il futuro sembrerebbe essere un altro), notevole è stato il successo ottenuto nell’amato est-Europa: Russia e Ucraina su tutti, ma anche Polonia, Slovacchia, ex-Jugoslavia, etc. Tra i paesi più “tradizionali”, a parte ovviamente (o forse non tanto?) l’Italia, diremmo Francia, Austria, America, Benelux e Grecia (anche qui vale lo stesso discorso fatto per l’Italia, forse questi non si possono, a rigore, annoverare tra i paesi “tradizionali”).
Domanda: Vi facciamo i conti in tasca: internet vi ha giovato in termini economici tanto quanto in quelli di popolarità?
Attilio: E’ impossibile rispondere in maniera esaustiva e precisa a questa domanda, perché se è vero che, a questo punto della carriera, dieci anni fa un album come “Dying In Time” molto probabilmente avrebbe venduto qualche migliaio di copie in più, d’altra parte senza internet (e tutte le possibilità che esso offre a una band agli inizi di farsi conoscere ed apprezzare) forse non saremmo arrivati dove siamo. Come sempre si deve affrontare il problema in maniera dialettica, cioè tenendo conto di tutte le dinamiche – anche e specie se contraddittorie – presenti. Quindi, se da una parte internet è determinante per tantissimi musicisti, come noi stessi, dall’altra però ne frena poi forse lo sviluppo vero e proprio. C’è stato un grande e positivo processo di democratizzazione (connesso proprio all’uso massivo di internet) che però alla fin fine ha reso più difficile emergere veramente e pienamente. A volte ho l’impressione che si rimanga tutti a mezz’acqua, in una sorta di limbo. Comunque per un gruppo indie del nostro livello i soldi provengono soprattutto dai concerti e i concerti arrivano se sei popolare (al di là dei dischi venduti piuttosto che solo scaricati più o meno illegalmente) e questo aspetto da internet è solo che favorito: quindi, in definitiva, quello che internet ti “frega” in termini di dischi venduti, te lo ridà sotto forma di concerti.
Domanda: A Catania avete suonato sulla spiaggia. Che effetto viene fuori unendo la vostra musica a una location così particolare?
Attilio: Location atipica senza dubbio; ci è capitato una sola altra volta, a Saint Malo in Francia all’interno della bella cornice del Route du Rock festival; lì suonammo dopo la performance di U. Schnauss, su una spiaggia immensa di fronte alle grigie e increspate onde dell’Atlantico. Sicuramente c’è un fascino particolare in contesti del genere, però allo stesso tempo non bisogna tacere di certi rischi connessi a questo tipo di performance suggestive. Rischi quali i problemi di acustica fondamentalmente: basti solo pensare alle varie sonorità che inevitabilmente si perdono in uno spazio aperto.
* Foto d’archivio
A cura di Emanuele Brunetto