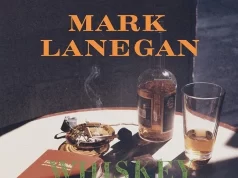Non attacco coi pompini, chi segue Il Cibicida conosce la mia (e dell’intera redazione) venerazione per Mark Lanegan, per ciò che è stato, è e (speriamo) sarà. Certo, il presente discografico non è idilliaco, il recente Phantom Radio è il punto più basso di una carriera fin qui encomiabile, pieno di canzoni deboli e arrangiate con suonacci da pianolina Bontempi. Ma checché se ne dica, la dimensione migliore per il cantante di Ellensburg rimane il palco, è lì che anche le sue creature più deboli trovano nuova linfa.
Non attacco coi pompini, chi segue Il Cibicida conosce la mia (e dell’intera redazione) venerazione per Mark Lanegan, per ciò che è stato, è e (speriamo) sarà. Certo, il presente discografico non è idilliaco, il recente Phantom Radio è il punto più basso di una carriera fin qui encomiabile, pieno di canzoni deboli e arrangiate con suonacci da pianolina Bontempi. Ma checché se ne dica, la dimensione migliore per il cantante di Ellensburg rimane il palco, è lì che anche le sue creature più deboli trovano nuova linfa.
Procedo con ordine. Arrivo come mio solito trafelato e bestemmiante davanti l’Alcatraz, il buon Emanuele Brunetto è già lì davanti che m’aspetta, entro e Duke Garwood ha già iniziato il suo set. Il folk-psichedelico destrutturato del cantautore britannico si rivela inadeguato per un posto grande come l’Alcatraz – che per l’occasione ha allestito il palco laterale e non capisco perché –, la sua dimensione perfetta è il piccolo club da cento teste al massimo con consumazione obbligatoria di doppio assenzio compresa nell’ingresso. È particolare il modo in cui suona la chitarra elettrica (che è baritona, quindi fa a meno del basso), ha un’impostazione da chitarrista classico, soprattutto con la mano destra, che gli consente un fingerpicking particolare. Riconosco un paio di brani del suo ultimo e interessante Heavy Love, tra cui Suppertime In Hell e la title track, per il resto faccio fatica a ricordare i titoli. Sul palco ci sono solo lui e il batterista Paul May, l’assenza di altri strumenti si avverte, i brani sono spogli e senza sussulti. Il cartellino in sovraimpressione sulle fronti di quelli che incrocio tra il pubblico recita lapidario: “mmm, sì, ok, intrigante, ma ora quando ti togli dai coglioni?”. Non è il posto adatto a lui, il pubblico rimane a temperatura ambiente e anche l’applausometro alla sua uscita raggiunge il minimo sindacale, più per buona creanza che per reale fibrillazione. Peccato, su disco mi era piaciuto molto.
Arriva Lanegan, si presenta sul palco con il nuovo chitarrista della band che lo supporta. Brevissima nota: quando lo vidi per il tour di “Blues Funeral”, due anni fa, ad accompagnarlo c’era un chitarrista fisionomicamente uguale a Johnny Cash, di una bravura ed un’eleganza sonora disarmanti. Questo nuovo, che si chiama Jeff Qualcosa, è abbastanza più rozzo e rock, ma difetta parecchio nei legati e anche nell’uso dello slide non è brillantissimo. Ma stando al set che suonerà, a Lanegan serviva qualcuno dal tocco più rude. Però Wannabe Johnny Cash spaccava i culi e rimane il mio preferito, sia chiaro. Nota finita.
Il live parte con When Your Number Isn’t Up e imbocca subito dopo la delicata Judgement Time, uno dei brani più convincenti di “Phantom Radio”. Mentre qualcuno dal pubblico urla a Lanegan di andare a Sanremo – tagliati la lingua la prossima volta, che l’Ariston è un letamaio – io ho la consueta fortuna di ritrovarmi accanto a tre tizi che ciarlano dei dischi che possiedono, di Lanegan e non. Appena trovo un varco più in là, riesco a sganciarmi dai fastidiosi Qui, Quo, Qua e a non sorbirmi più la loro esegesi della musica moderna di cui non me ne frega proprio nulla. Entra il resto della band sul palco e l’aria si scalda con The Gravedigger’s Song che è imbattibile anche dal vivo e con una sorprendente Quiver Syndrome, che liberata dalla sua cazzonaggine à la Dandy Warhol si tramuta in un grezzo e ruspante punk, con Lanegan che sembra preso davvero benissimo.
Monta l’eccitazione come le chiare per fare il soufflé e si continua con l’emotività dell’intramontabile One Way Street, Harvest Home che mi piace perché presentata in veste più rock, la toccante Deepest Shade (dall’album di cover “Imitations”, l’originale è dei Twilight Singers) e l’altro classico Hit The City (anche se il controcanto di Jeff Qualcosa non è certo quello di PJ Harvey, mi scusi messere se subisco il fascino estrogenico di quella voce suadente).
Certo, poi arriva quella mattonata sulle gonadi che è Ode To Sad Disco, lunghissima e spossante tanto da farmi persino distrarre e pensare a, boh, le acciughe del Mar Cantabrico o al perché non ho mai acquistato boxer che non fossero grigi o neri. Canzone per me bocciatissima da sempre. La fine del set è un po’ calante a parte una versione propano-altamente-infiammabile di Black Rose Way degli Screaming Trees (è contenuta in “Last Words” del 2011) che è talmente graffiante che mi dico: “Oh, ma la sta facendo davvero così cazzuta? Fico!”. Lanegan è sostanzialmente impeccabile, non stecca nulla, mantiene la stessa postura marmorizzata con mano-sinistra-sul-microfono-destra-sull’asta per tutta la durata del concerto, ma si muove più del solito, o meglio, beccheggia leggermente, sembra comunque in forma. Ah, dimenticavo una Riot In My House che mi fa fare un po’ di moderato headbanging proprio come mi consiglia il mio medico curante e Floor Of The Ocean che, tutto sommato, non disturba troppo la quiete.
Per gli encore arriva l’immancabile Metamphetamine Blues, sempre detonante, e per le finali I Am The Wolf e The Killing Season si unisce anche Duke Garwood, ma è più una comparsata di facciata che un reale contributo alla causa.
A 50 anni Lanegan continua comunque a dare carte e a dimostrarsi animale perfettamente a suo agio sul palco. Il pubblico ricambia entusiasta e non potrebbe essere altrimenti. Lui alla fine si slaccia un po’ e dice che Ci Ama Tutti. Noi pure ti amiamo all’unisono, Mark, ma al prossimo disco non farla più fuori dal vaso che “potremmo rimanere offesi” (il poliziotto Huber docet, con licenza temporal-verbale).
SETLIST: When Your Number Isn’t Up – Judgement Time – The Gravedigger’s Song – Harvest Home – Quiver Syndrome – One Way Street – Gray Goes Black – Deepest Shade (Twilight Singers cover) – Hit The City – Ode To Sad Disco – Riot In My House – Harborview Hospital – Floor Of The Ocean – Torn Red Heart – Black Rose Way (Screaming Trees) – Sleep With Me – Death Trip To Tulsa —encore— Methamphetamine Blues – I Am The Wolf – The Killing Season