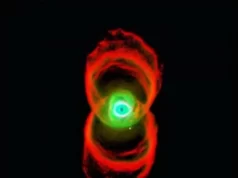Quante volte avete discusso con i vostri amici, con i vostri colleghi, con perfetti sconosciuti sui social, su quale fosse la più grande band del pianeta ancora in attività (che a dire Beatles o Pink Floyd siamo bravi tutti)? E quante volte vi siete trovati d’accordo con loro? Tante, la risposta alla prima domanda. Pochissime, quella per la seconda. Ne siamo certi. È normale, nel senso che trovare dei parametri oggettivi per una valutazione del genere è praticamente impossibile, a meno di affidarsi all’asettico sciorinare numeri e statistiche. Eppure a voler cercare un punto di incontro, un modo per valutare l’impatto di una band potrebbe essere quello di commisurare i numeri (di vendite, di streaming, di presenze ai loro concerti, etc.) al cuore, al grado di empatia suscitata nel pubblico. Ecco, i Pearl Jam da questo punto di vista sono ancora oggi un’esperienza con pochi pari, visto che ogni loro apparizione dal vivo si trasforma in un rito collettivo in cui a giro ciascuno dei presenti versa una lacrima, urla al cielo, abbraccia il vicino. E questo prescinde dall’apprezzare o meno la loro discografia, è qualcosa di tangibile di cui ha piena cognizione chiunque abbia presenziato almeno una volta a un loro concerto.
Le aspettative − quantomeno da parte di chi scrive − nei confronti di questo atteso ritorno dei Pearl Jam in Italia erano a dirla tutta bassine. Vuoi per gli anni di fermo che hanno fiaccato tanto il pubblico quanto gli artisti, dato che nessuno di noi è tornato lo stesso di prima, inutile nascondersi; vuoi per il recente nuovo lavoro solista di Eddie Vedder, tutt’altro che indimenticabile; vuoi per l’evoluzione della voce di Ed, che già da qualche anno ha perso dal vivo una parte importante del suo graffio e su disco trova modulazioni spesso non particolarmente convincenti. Invece quella che ancora una volta hanno messo in piedi i Pearl Jam è stata la consueta beatificazione del rock cui hanno abituato da ormai oltre trent’anni.
In apertura, oltre ai White Reaper con il loro garage d’annata, ci sono niente poco di meno che i Pixies, che si sparano un set tirato e pieno zeppo di quei pezzoni che hanno contribuito in modo sostanziale a tessere l’alternative rock degli anni ’90. Vestiti in total white, Frank Black e i suoi rispolverano i classiconi della loro produzione (tra cui le immancabili Here Comes Your Man e Where Is My Mind?, giusto per dirne due), instradando il pubblico verso quello che sarà il loro nuovo lavoro in studio, “Doggerel”, che arriverà il 30 Settembre e che presta il singolo There’s A Moon On alla setlist di Imola.
Poi i Pearl Jam, due estati d’attesa per una data che avrebbe dovuto tenersi il 5 Luglio del 2020, con il nuovo album “Gigaton” fresco d’uscita e che adesso è invece più vecchio di due anni, come noi, come la band, come il mondo. Dall’ultimo lavoro in studio i Pearl Jam tirano fuori il giusto, ovvero Dance Of The Clairvoyants (molto buono l’impatto live del pezzo, contro ogni più rosea previsione), Quick Escape, Seven O’Clock e Superblood Wolfmoon, calibrato assaggio di un disco che ha diviso la fanbase della formazione americana. Il resto della setlist, va da sé, è invece il greatest hits che tutti si aspettano, stavolta particolarmente incentrato sulla facciata più rock dei Pearl Jam: la partenza affidata a Corduroy detta il passo, poi Even Flow, Why Go, MFC, Jeremy, Do The Evolution e le rasoiate di Lukin e Porch che chiudono il set principale.
Eddie Vedder come sempre ha tanto da dire al proprio pubblico, più volte tra un brano e l’altro si sofferma a leggere qualcosa in italiano dai fogli che si è portato dietro sul palco. Ne ha per gli Stati Uniti, vista la recentissima presa di posizione anti-abortista, ma per lo più la sua è empatia e positività allo stato puro, come quando invita un padre con sua figlia tra le prime file a salire sul palco (“per sicurezza”), come quando racconta del suo continuo sognare l’Italia durante la pandemia (“è tutto vero? Sono qui?”), come quando dedica Come Back al fratello di un fan italiano, scomparso da poco a 44 anni. E sta tutto qui, in questo costante dialogo/scambio tra Eddie e la gente giù dal palco, l’essenza di una band come i Pearl Jam, forse più che nella musica stessa, forse più che nella performance in senso stretto.
Ecco, la performance: Mike McCready è l’assoluto mattatore del palco dei Pearl Jam, pochi dubbi al riguardo, dall’inizio alla fine è lui l’anima in musica della band, fino a quella Yellow Ledbetter che pone fine anche all’encore e che è da sempre uno dei suoi cavalli di battaglia. Dicevamo di Vedder e della sua voce: sono una band profondamente intelligente i Pearl Jam, a giro Stone Gossard, Matt Cameron e l’ultimo arrivato Josh Klinghoffer lo supportano alle controvoci senza mai risultare particolarmente invasivi, così come le tante divagazioni strumentali lo aiutano a riprendere fiato in mezzo a delle doppiette al fulmicotone. E tutto fila liscia come l’olio, tanto che sul finale, quando c’è da dare il meglio in State Of Love And Trust, Black, Better Man e l’inno Alive, Vedder è ancora lì fresco e potente come abbiamo imparato ad amarlo.
Ritornando al quesito iniziale, allora, possiamo considerare i Pearl Jam la più grande band in attività del pianeta? Magari no, ma quando ne trovate un’altra in grado di accendere sessantamila persone come fossero un unico enorme fiammifero, in grado di parlare al cuore di chi ascolta con lo stesso tono rassicurante che potrebbero avere un genitore o un fratello maggiore, fateci un fischio… nel frattempo è dalle loro parti che bisogna andare a cercare tutto ciò, perché i Pearl Jam non tradiscono mai.
SETLIST: Corduroy – Even Flow – Why Go – Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town – Dance Of The Clairvoyants – Quick Escape – MFC – Jeremy – Come Back – Save You – Wishlist – Do The Evolution – Seven O’Clock – Daughter – Given To Fly – Superblood Wolfmoon – Lukin – Porch —ENCORE— State Of Love And Trust – Black – Better Man – Alive – Yellow Ledbetter