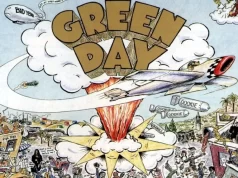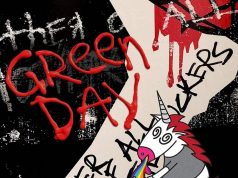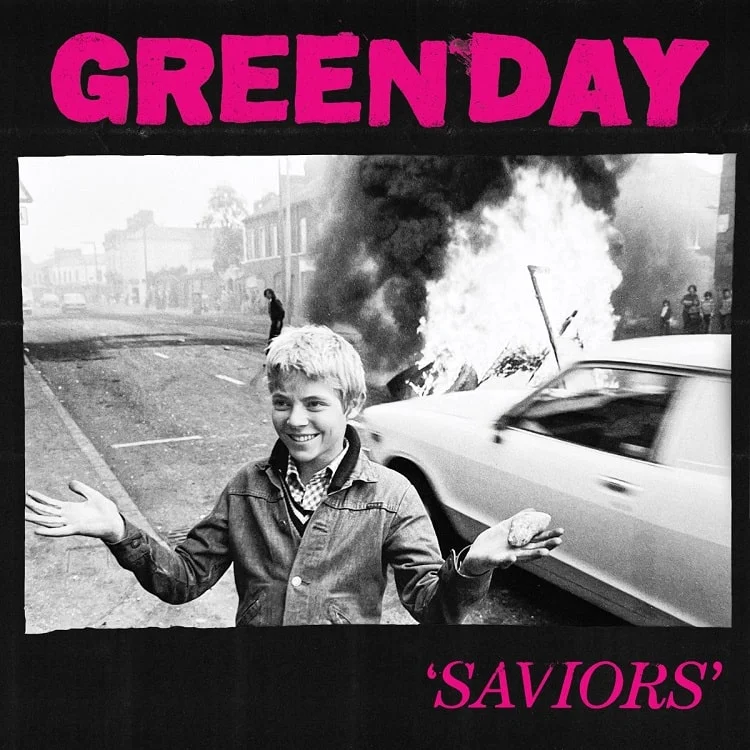
Era il Febbraio del 1994 quando una giovane band californiana pubblicava il suo terzo disco e il suo primo su etichetta major, con un titolo irriverente e un po’ infantile (“Dookie”, ovvero stronzo non in senso figurato ma letterale); in Agosto col suo secondo singolo, “Basket Case”, metaforicamente segnerà la fine dell’epoca della seria, cupa, dolorosa epopea del grunge per aprire quella del cosiddetto pop punk. Bye bye Seattle, nuvole, pioggia ed eroina, here we go California, sole, mare ed erba. L’etica dell’hardcore anni ’80 (che aveva informato in maniera molto importante anche tante delle band grunge) vola nel cesso, e questa presunta forma di punk abbraccia MTV, i frat party e poi, andando avanti nel tempo, diventa ispirazione per “la regina del pop punk” Avril Lavigne e altre mostruosità musicali come il successo dei Blink-182 e le colonne sonore dei film come “American Pie” e i suoi mille cloni.
Sì, lo sappiamo, sono passati quasi esattamente 30 anni, la nostalgia funge da amnistia per qualunque nefandezza e quindi figuriamoci se non possa fungere da amnistia per una band che comunque ha prodotto una quantità di solidi singoli pop (e persino qualcuno punk, come “Hitchin’ A Ride”, da “Insomniac” del ‘95); e difatti non siamo qui a disquisire delle nefandezze passate come “American Idiot” (2004), amatissimo quanto brutto album che segna forse l’apice del successo della band californiana. No, che il passato sia passato, il cugino puzzone ed ignorante nella grande famiglia del rock in fondo è pur sempre un membro della famiglia, e in fin dei conti se non gli si deve prestare soldi gli si vuole bene ugualmente.
Il problema, invece, è il presente. Nel passato prossimo, con l’obbrobrioso “Father Of All…” (2020) la band aveva basato la campagna promozionale dell’album sulla frase “No features, no Swedish songwriters, no trap beats, 100%, pure, uncut rock!”, evidenziando una totale assenza di percezione di se stessi e cercando di porsi verso il pubblico come uno dei (pochi) baluardi di (vero) rock’n’roll in un mondo di (finto) pop/trap o qualunque cosa accusino boomeristicamente di aver successo in loro vece, procedendo a produrre ventisei minuti di monnezza fumante durante la quale si finisce a pregare qualche autore svedese di scrivergli qualche cazzo di pezzo per amore del cielo, o che un beat trap di qualcuno con un mitra tatuato in faccia proceda a liberarci da questo abominio.
Quattro anni dopo, Billy Joe Armstrong dice di voler colmare il gap (?) con i suoi due capisaldi nella carriera: i citati “Dookie” e “American Idiot”, dei quali ricorre rispettivamente il 30esimo ed il 20esimo anniversario, e a quest’ultimo si aggancia tematicamente in maniera molto esplicita con l’onnipresente singolo The American Dream Is Killing Me, e ad entrambi si aggancia col ritorno di Rob Cavallo alla produzione, che da quel punto di vista fa un lavoro egregio per il tipo di album: produzione limpida, pulita, potente. Quello che manca non è però il suono pop punk radiofonico, ma, per prima cosa, i pezzi. One Eyed Bastard ricorda troppo da vicino l’agghiacciante “So What” di P!nk (che è più o meno punk quanto loro, cioè zero), consolidando una ormai granitica tradizione che risale a “Warning” (del 2000, che perlomeno “citava” i Kinks), ed è più o meno l’unico altro pezzo realmente memorabile del lotto, nonostante l’aberrante ritornello “bada bing, bada bing, bada boom”.
Ma quello che veramente salta all’occhio (o meglio all’orecchio) è come, se in casi come quello dei veterani Green Day la tendenza è quella di cercare di sembrare i se stessi dei momenti di gloria, qui i Green Day cercano (inconsciamente?) in qualche modo di sembrare i loro epigoni del passato, come i Wheatus, i Lit o qualche cosa di simile, dimenticando che ciò che salvava gli album dei Green Day (o degli Offspring) rispetto ad altre band simili era una massiccia dose di personalità, tale da innalzare (alcuni) pezzi e renderli persino importanti nella storia di un genere.
E allora Saviors – il cui titolo, fortunatamente, non allude ai nostri ma alla necessità di salvatori in un mondo alla deriva – a dispetto di tematiche non banali forse trattate in maniera superficiale dà un po’ quella sensazione di Pausammerda e Mamma di Stifler. Lo sappiamo, oggi per un critico musicale (ma anche cinematografico, letterario, d’arte) non è chic criticare. Assistiamo a una sequela di elogi ad album brutti di ieri e di oggi, qualunque imbarazzante prodotto rivalutato e consegnato alla gloria eterna, qualunque mediocre artista (a maggior ragione se dei “bei tempi andati”) viene osannato, e gli si concedono tributi ed elogi.
E se proprio non c’è veramente un cazzo da salvare, una dignitosa sufficienza, una sequela di “tuttavia” concilianti ad ogni moderata critica, portano a casa la giornata, che la shitstorm sta sempre dietro l’angolo. Ma ci dispiace se non ci accodiamo: “Saviors” è un album brutto, a partire dall’americana bruttezza dello spelling della parola. Sicuramente ci sarà chi, nel diagramma di Wenn che intreccia nostalgici dei primi anni 2000, fan del pecoreccio americano (quello con Jason Biggs e playmates invece di Lino Banfi ed Edwige Fenech, per capirci) e amanti di musica di pessimo gusto, sarà esaltato da questa magnifica notizia, ma, con tutto il rispetto per chi è reso felice da “Saviors”, consentiteci di saltare questo giro di “remember when”.
2024 | Reprise
IN BREVE: 1/5