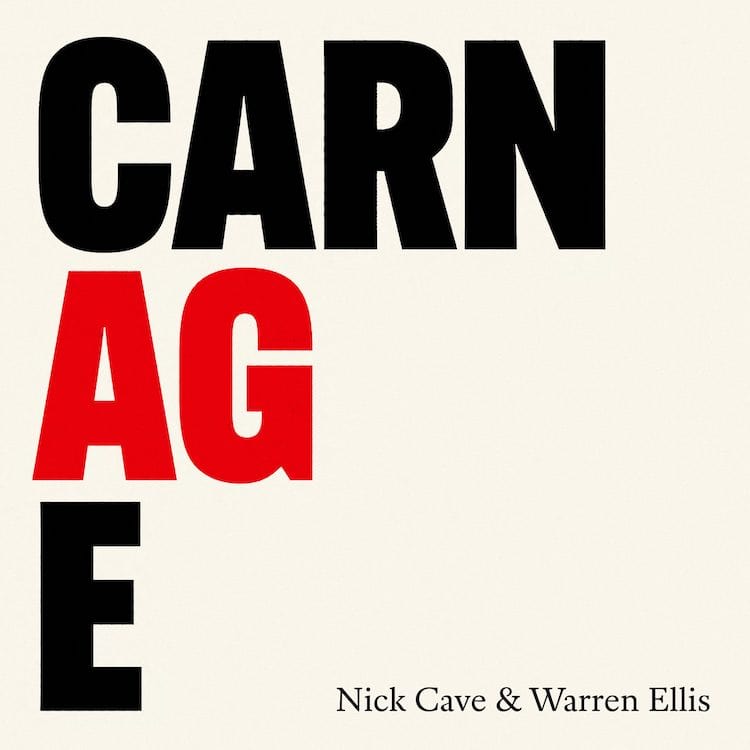
La lunga camminata che si vede all’inizio del live registrato all’Alexandra Palace, durante la prima parte dell’anno “pandemico” appena trascorso, in cui Nick Cave attraversa vari luoghi prima di raggiungere la sala del piano, è l’esemplificazione perfetta dell’ultimo decennio carrieristico dell’ex leader dei Birthday Party. Andatura rigida, raminga, ferma nel suo dolore e nella consapevolezza della transizione. Il cambiamento, inteso come evoluzione, nel Re Inkiostro è stata una forma di sopravvivenza del suo estro artistico, talvolta inevitabile, come nell’ultimo lustro. La perdita, l’elaborazione del lutto, la necessità di dare una dimensione a quel dolore hanno contribuito alla genesi di lavori più intimi e struggenti.
Ritornando alla scena evocata all’inizio, l’attraversamento di quei luoghi simboleggia, per l’appunto, un cambiamento, un nuovo e ulteriore step nella carriera di Cave, ancora una volta dettato dall’urgenza emotiva influenzata dagli accadimenti circostanti. Questa volta la pandemia e il lockdown: la sospensione dell’uomo ha innescato il turbinio creativo delle elucubrazioni poetiche e sonore del cantautore australiano, orfano dei Bad Seeds ma non dell’onnipresente Warren Ellis. Carnage è il frutto di questa dialettica emergenziale: Cave detta, Ellis esegue e viceversa, in questo mutuo scambio costante di parole e suoni. Questo flusso si manifesta mediante un’impostazione ossimorica che lega una scrittura simbolica e inquieta a sonorità placide, talvolta oniriche. Tuttavia, c’è una novità che si percepisce immediatamente ed è l’evidente intenzione di rimescolare le carte: l’inquietudine sembra essersi riappropriata anche delle partiture musicali.
I fantasmi di Cave e di Ellis avanzano a braccetto sulle prime note del pezzo d’apertura, prima che la metratura sghemba delle ritmiche li faccia cadere in un oblio di ossessioni antiche. Ecco: Hand Of God è il primo tassello di questa carneficina silente, che non ha bisogno di clamore per essere raccontata. Un tappeto quasi industrial, fatto di glitch rarefatti e archi distorti, accompagna la litania pagana di Cave che invoca un intervento dall’alto, più punitivo che salvifico – verso se stesso. Il testo di Old Time riprende il tema del viaggio e del ritorno, infarcendolo di riferimenti autobiografici come in “The Sick Bag Song”, diario di viaggio di Cave pubblicato qualche anno fa. Il ronzio marziale del basso guida il cantato tra piani onirici e chitarre distorte, luoghi sonori meno esplosivi ma comunque vicini alle atmosfere umbratili composte con i Bad Seeds.
La title track, a differenza di quanto possa far pensare il titolo, è una ballata malinconica in cui il protagonista, leggendo svogliatamente Flannery O’Connor – autrice molto apprezzata da Cave – si strugge nel ricordare la sua amata e paragona il suo sentimento a una giornata di pioggia. Le note quasi concilianti del piano e degli archi sono sovvertite, poi, dall’incedere nervoso di White Elephant, un pezzo dal chiaro DNA schizofrenico non lontano da certe trame sonore del passato (“The Good Son” e “Abbattoir Blues”). È un brano politico: i richiami al Black Lives Matter e a George Floyd sono evidenti (“A protester kneels on the neck of a statue / The statue says ‘I can’t breathe’ / The protester says ‘Now you know how it feels’ / And he kicks it into the sea”) e ben si sposano con il blues distorto e asfittico sciorinato nella prima parte del brano. La seconda, invece, è un’epifania gospel che invoca il regno dei cieli e che invia un messaggio di redenzione ai suprematisti bianchi, principali destinatari delle rivendicazioni del movimento attivista.
Da qui in poi, Cave ed Ellis assumono toni concilianti e meno febbrili: le delicate melodie di Albuquerque fanno da apripista alle atmosfere cinematiche di Lavender Fields, i cui archi sembrano presi in prestito da una delle colonne sonore del collaudato duo. La chiusura è affidata a Balcony Man, elegante ballata al piano in cui viene rappresentata la metafora dell’attesa nella prospettiva di un uomo al balcone. Toni speranzosi sembrano accompagnare la fine del disco, ma è solo un’illusione: il crudo realismo del verso finale (“And what doesn’t kill you just makes you crazier”) trancia di netto ogni dubbio. Tirando le somme, “Carnage” è un disco ebbro di poesia e di inquietudine, in cui, al netto delle incursioni spirituali e dei costanti riferimenti biblici, è il Cave fatalista a spuntarla.
(2021, Goliath Enterprises Limited)
01 Hand Of God
02 Old Time
03 Carnage
04 White Elephant
05 Albuquerque
06 Lavender Fields
07 Shattered Ground
08 Balcony Man
IN BREVE: 4/5



![TOP [50] ALBUM [2024]](https://www.ilcibicida.com/images/2024/12/awards2024-238x178.png)

![TOP [50] ALBUM [2021]](https://www.ilcibicida.com/images/2021/12/awards2021-238x178.jpg)