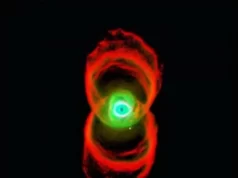“Confusione”. La prima parola dopo sette anni è questa. La sferra Eddie Vedder mentre si ripara dalla pioggia acida di tastiere e drum machine in Dance Of The Clairvoyants. La sua voce è tirata, scrocchia la mandibola, la pelle solcata dalle vene. Sette anni di stop. I Pearl Jam non se ne erano concessi mai così tanti. In mezzo, chilometri di tour, alcuni stop fisiologici altri più tragici. E poi la confusione. Il caos di un mondo oggi addirittura in quarantena globale. Disastri climatici, sovranismi politici. Chiaroveggenza. Confusione.
I Pearl Jam arrivano a Gigaton da band cinquantenne, è il primo album su quelle cifre e sembra quasi che, per l’occasione, abbiano voluto aggredire la confusione per sparigliare le carte. “La regola era non avere regole” – ha detto Josh Evans, il co-produttre. Uno che ai tempi di “Ten” (1991) aveva tredici anni e che ora si è ritrovato a mescolare le carte di un lavoro volutamente cangiante, confuso, “no code” – si potrebbe dire. I Pearl Jam avevano bisogno di qualcuno che girasse verso di loro uno specchio proponendogli una diversa rappresentazione di sé. O meglio, diverse rappresentazioni di band.
È per questo che tra i territori funk di Dance Of The Clairvoyants e quelli folk sinistri di Buckle Up c’è un mondo, una divisione fisica neanche troppo virtuale visto il metodo di lavoro scelto. Registrazioni puzzle, due membri per volta, pezzetto per pezzetto, con valzer delle posizioni e degli strumenti. Un taglia e cuci. È per questo che tra il binomio “into-the-wild” Retrogade / Cross River (eco, organo, canzoni da frontiera che, del formidabile album da solista di Vedder del 2007, riprendono il concetto di natura ferita da una società disumana, “crazy breed”) a quello punk tirato Never Destination / Take The Long Way, passando per le tastiere anni ‘80 di Seven O’Clock, ci si muove con incertezza.
Ancora prima, Quick Escape aveva “citato” i Led Zeppelin nel riff di “Kashmir” oltre al ritornello di “School” dei Nirvana; Alright era piombata epica (forse troppo) con aperture pompose. E poi, dopo, Comes Then Goes, con arpeggio blues su coro decadente, è l’addio a Chris Cornell (“Dove sei stato? Potrei avere un barlume del mio amico?”). La morte di Cornell, nel Maggio del 2017, ha rappresentato per la band un anno zero. Non solo la perdita di un amico, ma una vera e propria cesura esistenziale.
“Gigaton” è un disco di maree: s’alza, s’abbassa, copre la battigia, poi la lascia nuda. I Pearl Jam non hanno più nelle loro corde brani memorabili, ovvero “che si ricordano nel tempo”. Sono finiti i tempi degli inni, dei brani costruiti per costruirsi un percorso da soli. Le canzoni di “Gigaton” vanno scoperte, ti lasciano, ti riprendono un pomeriggio con poca luce leggera, forse ti mollano ancora a sera. Pezzi, quindi, che vivono piene, poi secche. Sbalzi di umore, sbalzi di temperatura. Confusione, insomma. Nel frattempo fuori si sta decomponendo un mondo. Si disperde velocemente il senso. Sulla copertina di “Gigaton” una parete di ghiacciaio si sta sciogliendo. Il cielo è minaccioso, severo. Il mare grigio e ondeggiante. È la fine del mondo? “Quando il passato è il presente e il futuro non c’è più” canta Eddie, il chiaroveggente.
(2020, Republic)
01 Who Ever Said
02 Superblood Wolfmoon
03 Dance Of The Clairvoyants
04 Quick Escape
05 Alright
06 Seven O’Clock
07 Never Destination
08 Take The Long Way
09 Buckle Up
10 Comes Then Goes
11 Retrograde
12 River Cross
IN BREVE: 3,5/5