 Si sa, il concept è un po’ la fissa di ogni artista/band che punti a entrare nella storia del rock. Magari l’obiettivo può essere raggiunto per altre vie, ma beccando la tematica giusta e il lampo storico giusto per tirarla fuori, un concept può davvero rappresentare quel quid pluris che ogni discografia che si rispetti agogna.
Si sa, il concept è un po’ la fissa di ogni artista/band che punti a entrare nella storia del rock. Magari l’obiettivo può essere raggiunto per altre vie, ma beccando la tematica giusta e il lampo storico giusto per tirarla fuori, un concept può davvero rappresentare quel quid pluris che ogni discografia che si rispetti agogna.
A Polly Jean Harvey il concept mancava. Nei suoi album, un bel po’ negli ultimi venti anni, certi temi si sono ripetuti spesso, a sprazzi regolari: dalla maternità ai tribolati rapporti fra uomo e donna, passando per i suoi visionari voli mentali. Mai in un corpo unico, però. Quale miglior momento, allora, di questo 2011 per prendere il proprio Paese, l’Inghilterra, e rigirarlo come un calzino usato prima di ficcarlo in lavatrice? E quale miglior argomento della guerra, in un periodo in cui quasi all’ordine del giorno si sente nei telegiornali di militari vittime negli scontri mediorientali? Con i britannici in prima fila, of course.
Ecco, PJ non s’è lasciata sfuggire l’occasione e ha partorito questo Let England Shake, ad oltre tre anni di distanza dal precedente “White Chalk” (2007). Dal punto di vista concettuale, al di là delle parole “England”, “America”, “soldiers” o “murder” che compaiono qua e là sparse nelle lyrics e nei titoli dei brani, la guerra narrata da PJ Harvey non è quella sixties di Bob Dylan, né quella civile degli U2 o quella anthemica di Bruce Springsteen. E se proprio un paragone va trovato, lo si riscontra nei connazionali Pink Floyd, che hanno spesso dipinto la guerra come una faccenda del singolo più che della collettività. Parla di guerra PJ, ma non ne fa una questione meramente politica, quanto piuttosto un tuffo nell’animo umano, per comprendere la guerra come contrasto, come contrapposizione, come emblema di quel muro contro muro (floydiano) da sempre fra le massime – nel senso di minime – espressioni della razza umana.
Musicalmente, invece, quello di Polly Jean è un salto all’indietro di un bel po’ di anni. La Harvey si riappropria della forma canzone, leggermente bistrattata nelle ultime uscite, favorendo il reinserimento delle chitarre e un approccio decisamente meno sperimentale. Ciò nonostante, elementi che disorientano l’ascolto ce ne sono comunque: vedi The Glorious Land, con quella marcia militare fatta con la tromba che fa più volte capolino in sottofondo, i ritmatissimi controcori di The World That Maketh Murder o l’incedere latino di On Battleship Hill. E poi sax, pianoforte, tastiere ed inserti vari, tutto un campionario di orpelli che però non risultano mai invasivi o protagonisti dei brani, relegati al ruolo di substrato atmosferico.
C’è anche spazio per una traccia come Bitter Branches, la più harveyana del lotto, che poteva tranquillamente essere contenuta in “Uh Huh Her” (2004) o, meglio ancora, in “Stories From The City, Stories From The Sea” (2000). E poi c’è la voce di PJ, che mai come in questo lavoro era sembrata consapevole delle proprie potenzialità: sensuale, gracchiante, stonata, dissonante, eterea. Aggettivi che difficilmente convivono fra loro ma che in “Let England Shake” calzano tutti a pennello. Magari è ancora presto per dirlo, ma quest’album ha tutte le sembianze del passo definitivo della carriera di PJ Harvey.
(2011, Vagrant)
01 Let Engalnd Shake
02 The Last Living Rose
03 The Glorious Land
04 The Words That Maketh Murder
05 All And Everyone
06 On Battleship Hills
07 England
08 In The Dark Places
09 Bitter Branches
10 Hanging In The Wire
11 Written On The Forehead
12 The Colour Of The Heart
IN BREVE: 4,5/5


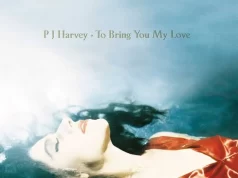
![TOP [50] ALBUM [2023]](https://www.ilcibicida.com/images/2023/12/awards2023-238x178.jpg)