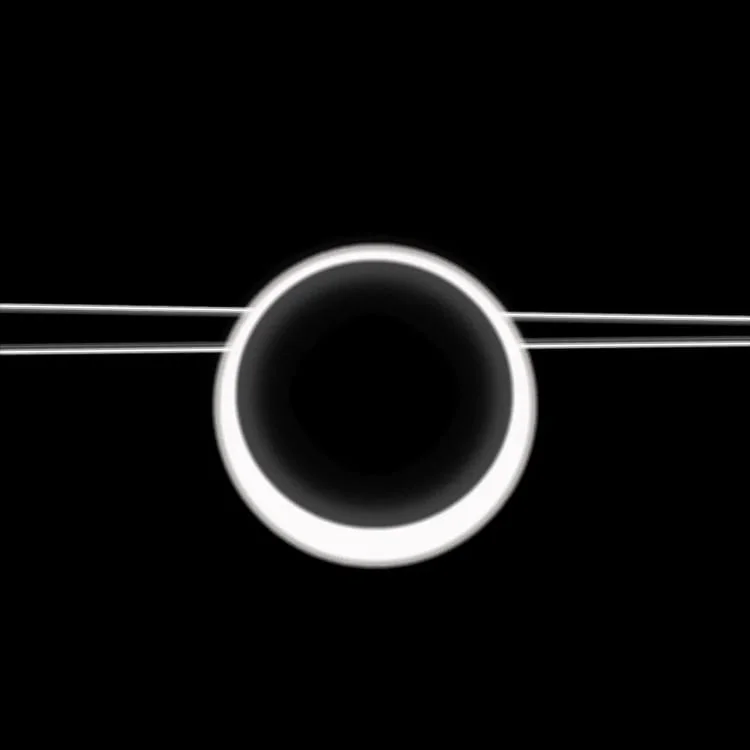
Dicembre, 1995. Da solo, nella mia stanza, ormai ho da tempo incominciato ad ascoltare la mia musica, quella che non ha contatto con genitori o zii. Musica che ho scoperto da solo, tramite le riviste musicali (bestiale, ai tempi c’era chi le leggeva e – Iddio ci salvi! – scopriva pure musica interessante tramite articoli e recensioni) o gli amici, o i fratelli maggiori degli amici. Un album ha attirato l’attenzione mia e di quegli amici che hanno intrapreso il mio stesso cammino spiritual/musicale: ha un ritratto di donna mezzo rinascimentale o chissà di che cazzo, che si staglia in un cielo blu, stellato, con dei pianeti sullo sfondo in copertina. Io, che l’inglese (secondo me) lo so bene, sono discretamente confuso dal nome della band e dal titolo dell’album: “Smashing Pumpkins”? E che cazzo vuol dire? Scassare zucche? (No, non vuol dire questo. “Think British” disse cripticamente Corgan, che adesso capisco) “Mellon Collie”? Boh. L’ha comprato un amico che sta messo meglio di me, d’altra parte è un doppio CD e ciò significa un costo non inferiore alle quarantamila lire, se va bene. Alla seconda canzone, sono già fottuto: “Time is never time at all”. Inizia l’adolescenza, fianco a fianco a Corgan e ai suoi testi perfettamente adolescenziali.
Aprile, 2000. Sono in gita a Firenze con la mia classe. Compro “Machina/The Machines Of God”, quinto album dei Pumpkins. Avevo comprato il CD singolo di “Stand Inside Your Love”, incredibilmente non esaltante; “incredibilmente” perché fino a quel punto io dei Pumpkins ho amato tutto, ho comprato singoli, scaricato bootleg (alla bellezza di 5kb/s su Napster, che significava, bene che andasse, una mezzoretta a canzone), letto interviste e visto video, ufficiali e non. Non lo ammetto a voce alta, ma “Stand Inside Your Love” è abbastanza mediocruzza. Però non lo era “The Everlasting Gaze”, della quale era uscito il video. Billy dice che è un ritorno al rock questo; il mezzo elettronico, mezzo acustico, mezzo pop “Adore” era bellissimo, ma non era andato un granché bene, almeno paragonandolo a “Mellon Collie”. Non ho voglia di ascoltarlo in gita, mi dico, perché mancherebbe la sacralità del rituale dell’album nuovo della band del cuore – cazzate. Prima di tutto è il terzo album che esce da quando sono fan, “Mellon Collie” incluso, quindi rituale un cazzo; si potrebbero contare nel rituale anche l’acquisto e conseguente ascolto degli album più vecchi, ma non è quello il motivo. Il motivo è un presentimento. Un atroce presentimento.
Agosto, 2024. Se riuscissi a telefonare a me stesso in uno dei due momenti precedenti del passato per dirmi che la cosa più interessante fatta da Corgan negli ultimi venticinque anni è stata acquistare e dirigere la storica National Wrestling Alliance, risponderei come fece Cartman a se stesso in un’evenienza simile (“Fuck you, asshole. You can go fuck yourself!”). Eppure non starei mentendo. Dopo il mediocre “Machina” (che era comunque meglio di tutto ciò che stava per venire), Corgan ha sottoposto i suoi fans ad una sempre più tediosa tortura, l’atroce “Machina II”, l’aberrante disco solista, il demenziale progetto Zwan e una striscia ininterrotta di mattoni fra i quali “ATUM” (2023), ideale capitolo finale – secondo lui – di una trilogia che include proprio “Mellon Collie” e “Machina”, 138 minuti di sfracanamento di coglioni allucinante nel quale il concept (già di difficile digeribilità una volta superata l’adolescenza) diventa intollerabile, fa mancare il respiro dalla noia. Ed ecco che arriva il “ritorno al rock”, ancora una volta, come venticinque anni fa, il cui titolo di difficile decrittazione (Aghori Mhori Mei) un tempo avrei smosso mari e monti per capire, ma che oggi mi fa girare gli occhi al cielo e sbuffare come una teenager viziata alla quale la mamma ha detto che non può andare a vedere i Coldplay per la quarta volta.
Avrà capito anche il lettore meno attento che già l’improba attività di recensire un album in maniera oggettiva è in questo caso non improba ma improbabile: gli antecedenti tra me e Corgan sono complicati, e sentirgli dire che il disco “suona molto come la versione della band di Siamese Dream e Mellon Collie” mi fa provare le emozioni che proverebbe un uomo a sentire la moglie che dice al giudice nell’udienza per il divorzio che, finalmente, lei ha messo la testa a posto e non lascerà più soli i bambini per andare a giocare al Bingo, e che con le sigarette ha quasi smesso.
Eppure, quando per l’ennesima volta premo play sperando in qualcosa di dignitoso che non arriva mai – come accaduto per venticinque lunghi anni – Edin sembra incredibilmente aver spezzato il circolo vizioso letale che da anni ci consuma: un fottuto pezzo più che dignitoso, anzi – diciamolo sottovoce – un grande pezzo rock che ricorda i fasti passati! E dai Billy, ci siamo stramaledetto frolloccone gigante e pallido, ci siamo! E la speranza è dentro al cuore, ma arriva immediatamente Pentagrams a cancellarla, la solita, insostenibile nenia (“Love never dies / As true / Real and mine / For always / Forever I / Love never dies”) nella quale qualunque idea di riff viene annientata dalla nasale voce di Corgan e da questa melodia lamentosa quanto banale. Ed eccoci qua, ancora una volta, a sopportare quarantacinque minuti di cazzate e titoli incomprensibili, e soprattutto di noia, di noia che annichilisce qualunque volontà di ritornare su quest’album. Con quelli precedenti ci ho provato eh, Iddio mi è testimone di quanto ci abbia provato. Ma al tredicesimo album di studio, concedetemi il lusso di non cascarci più. I bambini sono in casa, soli, anche se ormai abbondantemente maggiorenni. Al Bingo gente che puzza di Iqos cancella i numeretti con il pennarello.
È incredibile come un uomo appassionato di wrestling al punto da comprarne la più antica federazione in attività, da questo sport-spettacolo non riesca a carpire il suo più importante concetto ed il segreto della sua longevità: un’amabile, quasi ottusa, semplicità. Una linearità nei concetti che in qualunque momento di difficoltà ti aiuta ad uscirne fuori. Oppure il vero segreto era un altro e nessuno di noi l’aveva capito: D’Arcy Wretzky. Non ha mai scritto pezzi in nessun album (e in “Siamese Dream” e “Machina” si dice che non suoni neanche il basso lei ma Corgan), ma forse era lei la musa? Boh, ragazzi, cosa volete che vi dica, ho avuto una brutta giornata, e odio i fottuti Pumpkins.
2024 | Martha’s Music/Thirty Tiger
IN BREVE: 2/5






