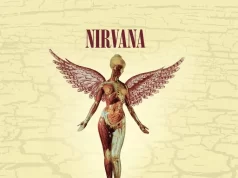Alla luce di ciò che è venuto dopo, in tanti considerano − magari un po’ ingenerosamente − gli anni ’90 l’ultimo decennio in cui è avvenuta qualcosa di davvero rilevante e seminale per la storia del rock. E all’interno dei nineties, l’anno ritenuto come il fondamentale turning point è senza dubbio il 1991, grazie alla vagonata di dischi rivelatisi epocali che furono pubblicati nel corso di quei dodici mesi. Neanche a dirlo, fu soprattutto dalle parti di Seattle che la svolta dell’alternative rock prese in quell’anno piede, con il fenomeno grunge in vertiginosa ascesa grazie ad una manciata di band che iniziarono ad emergere da un ribollente brodo primordiale che pullulava di piccole e medie realtà. Senza fare torto ad altri (specie a due band fenomenali come Soundgarden ed Alice In Chains, già messesi in mostra), lo step decisivo che consentì al grunge di salire di livello attirando le attenzioni di mezzo mondo lo si deve a due dischi: “Ten” dei Pearl Jam, uscito a fine Agosto, e neanche un mese dopo Nevermind, che spezzò definitivamente ogni ritrosia commerciale nei confronti di una scena che non era più possibile tenere intrappolata in quel lontano Nord-Ovest degli Stati Uniti dov’era nata.
Mentre per “Ten” si trattò di un esordio, ma di una band con al suo interno musicisti che s’erano già distinti in città (e non solo), per i Nirvana si trattava invece del secondo album. Kurt Cobain era fondamentalmente un punk, ma con una visione piuttosto chiara di ciò che voleva e di ciò che avrebbe voluto raggiungere con e nella musica. “Bleach”, che nel 1989 aveva fatto esordire i suoi Nirvana per l’indipendente Sub Pop Records (che avrebbe avuto un ruolo tutt’altro che marginale nell’affermazione della città di Seattle come nuovo fulcro del rock americano), non aveva avuto la cassa di risonanza che Cobain s’aspettava, complici anche le disponibilità certo non faraoniche dell’etichetta in fase di promozione. Cobain viveva costantemente in bilico tra integralismo artistico e velleità da rockstar, così mentre lui e Krist Novoselic (e con la posizione di batterista ancora in sospeso, prima che arrivasse Dave Grohl a ricoprirla) lavoravano ai demo per il loro secondo album su Sub Pop, in realtà erano in corso varie trattative condotte personalmente da Cobain per fare il salto in una major che avrebbe potuto garantire ai Nirvana maggiore visibilità.
Complici i consigli degli amici Sonic Youth a spuntarla fu la Geffen, che mise sotto contratto i Nirvana aspettandosi che nella migliore delle ipotesi Cobain e la sua band potessero pareggiare proprio i risultati ottenuti dalla formazione guidata da Thurston Moore. Cobain sapeva dove andare a parare, sapeva che “Bleach” era un album sporco che non avrebbe mai potuto sfondare, così per il secondo album dei Nirvana voleva a tutti i costi trovare il miglior equilibrio possibile tra rumore e melodia, tra punk e pop, qualcosa che aveva già visto fare con successo (ma niente di paragonabile a quello che avrebbe avuto lui) ai Pixies, uno dei suoi punti di riferimento. Occorreva dunque lavorare sulla produzione del disco, così su consiglio dello stesso boss della Sub Pop Bruce Pavitt i Nirvana si erano rivolti a Butch Vig, una scelta che avrebbe segnato profondamente le sorti dell’album che la band si apprestava a registrare.
Vig, scelto dalla band quando ancora il disco doveva uscire su Sub Pop e confermato nella stanza dei bottoni anche in seguito, nonostante la nuova etichetta volesse affidare la produzione a qualcun altro, lavorò esattamente nella direzione voluta da Cobain, addolcendo le asperità dei primi Nirvana e arrotondando il suono della band anche nei passaggi del disco più scroscianti. Il produttore avrebbe anche dovuto occuparsi del missaggio, ma si decise poi di virare sui servigi di Andy Wallace, con il risultato che fu quella bomba atomica destinata a sconquassare Seattle e il rock mondiale. Ma il lavoro svolto da Vig e Wallace fu talmente perfetto da rivelarsi persino “troppo”, quantomeno agli occhi della band, che fin da subito ritenne il disco tutt’altro che aderente all’imprinting punk che i Nirvana volevano comunque mantenere, tanto da portare Cobain stesso a dichiarare in più di un’occasione di sentirsi a disagio nel riascoltare l’album.
A prescindere dall’analisi ex post di Cobain, frutto probabilmente anche di una comprensibile incapacità nell’affrontare i riflettori del mondo puntati addosso anche quando stava seduto sul cesso, “Nevermind” fu una botta pazzesca proprio grazie/a causa del modo in cui venne prodotto, per il modo in cui vennero registrate le chitarre di Cobain, diventate un classico istantaneo del sound dei ’90 e da quel momento in poi faro per una miriade di musicisti, per l’apporto fresco e violento della batteria di Grohl, per quell’effetto dissonante che rendeva la tracklist del disco una sorta di mostro a due teste in cui i Black Flag suonavano pezzi dei Beatles. Una formula semplicemente perfetta portata a livelli d’eccellenza dal songwriting ermetico e spesso nonsense di Cobain, che dall’alto della sua rabbia post adolescenziale era riuscito a impersonare in neanche un’ora il disagio e la frustrazione di un’intera generazione che l’avrebbe eletto, suo malgrado, a proprio rappresentante.