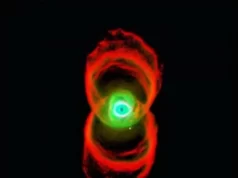Non può certo dirsi che i Pearl Jam non avessero avvertito chiaramente il proprio pubblico sulla natura del loro quarto lavoro in studio, già a partire dal titolo: No Code, nessun codice, nessuna codificazione. In parole povere niente copione da seguire alla cieca e senza farsi domande, perché era il 1996 e il grunge proprio in quell’anno avrebbe subito il contraccolpo definitivo dovuto alla scomparsa di Kurt Cobain, avvenuta due anni prima. C’erano ancora tutti in circolazione, compresi Soundgarden e Alice In Chains, ma era evidente che un’epoca stava per concludersi e che i suoi protagonisti avrebbero giocoforza dovuto raddrizzare il tiro delle rispettive carriere.
A dire il vero i Pearl Jam già col precedente “Vitalogy” (1994) avevano dato segnali di insofferenza verso una formula che calzava stretta soprattutto a Eddie Vedder, da sempre più instradato verso una dimensione fatta di rock più classico, sulla scia del maestro Neil Young. A partire dalla “Black” di “Ten” (1991), passando per la “Indifference” di “Vs.” (1993) e le varie “Nothingman”, “Better Man” e “Immortality” di “Vitalogy”, quello di Vedder era stato un lungo percorso di ricerca di una forma diversa per quella che si stava trasformando ogni giorno di più nella sua band, una forma che potesse andare oltre l’hard rock e il punk instillato in praticamente qualsiasi cosa uscisse da Seattle in quella prima metà degli anni ’90.
“No Code” arriva un po’ in sordina, i Pearl Jam avevano subito la fatica del lungo tour a supporto di “Vitalogy”, avevano cambiato ancora una volta batterista ingaggiando l’amico Jack Irons e, come ormai loro consuetudine, avevano decisamente poca voglia di abbandonarsi alla canonica promozione discografica. Così l’album si rivela per quello che è, ovvero un disco di passaggio, pieno zeppo di semi tra i più disparati − alcuni dei quali avrebbero germogliato, portando alla definitiva quadratura della macchina Pearl Jam, mentre altri sarebbero rimasti lì a seccare − e con tanti passaggi che hanno più le sembianze del divertissement che dell’opera ragionata (su tutti la dinosaurjriana Mankind, primo pezzo nella storia dei Pearl Jam con un testo né scritto né cantato da Vedder, visto che fa tutto Stone Gossard).
L’incipit affidato alla riflessiva Sometimes la dice lunga, visto che i Pearl Jam non avevano mai inaugurato un disco in modo così vellutato, chiaro segnale di cesura rispetto al passato più e meno recente, per non parlare delle vene etniche e tribali di Who You Are, scelta addirittura come primo singolo. Un po’ un suicidio per una band col background dei Pearl Jam, associato peraltro alla loro totale ritrosia nel rilasciare qualsivoglia intervista a supporto della pubblicazione dell’album. Sulla stessa falsariga di Who You Are c’è anche la seguente In My Tree, e poi il folk rotondo di Off He Goes, l’arzigogolato incedere di Present Tense, la conclusiva nenia Around The Bend e persino lo scurissimo e stralunato spoken di I’m Open. Non viene dunque difficile credere come in tanti faticassero a riconoscere la stessa band nella tracklist di “No Code”. Qualche gancio con i Pearl Jam degli esordi lo si trova nelle sole Hail, Hail e Habit, che si fregiano della solita prova al fulmicotone di Mike McCready, oltre che nella breve e tiratissima Lukin, mentre Smile e Red Mosquito si adagiano pesanti su territori youngiani.
“No Code” non pagò, nel senso che larga fetta dei fan dei Pearl Jam lo considerarono − e tanti lo considerano tutt’ora − l’anello debole della loro produzione fino a quel momento, oltre a non aver pagato in quanto a vendite, buone ma certo non del tutto in linea con le aspettative commerciali che una band come i Pearl Jam era ormai chiamata a soddisfare. Ma, come dicevamo poco sopra, “No Code” è stato un ponte indispensabile per arrivare ai Pearl Jam come li conosciamo oggi e tanto basta.