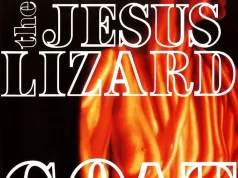C’è – di sicuro c’è stata – una costante nell’intera vita/carriera di Trent Reznor, una costante comune a molti e in molti contesti, ma che in lui ha pericolosamente lambito i contorni della malattia: l’ambizione. Efferata, feroce, catalizzante e quasi disumanizzante, così tanto da averlo portato più e più volte sull’orlo di un baratro che solo per caso, per fortunate circostanze o più probabilmente per risorse interiori che lui stesso non pensava di avere, non l’ha visto precipitare rovinosamente di sotto. Ed è l’ambizione – oltre che il talento, va da sé – tanto artistica quanto umana ad averlo portato dov’è adesso, nome tra i più luminosi di quella Hollywood cui un tempo avrebbe strappato a morsi il cuore dal petto.
A metà anni ’80 Reznor, originario della Pennsylvania, si barcamena a Cleveland, Ohio come manovalanza nel mondo della musica, ma gli è chiaro come il suo ruolo non debba essere quello di stare al servizio di altri ma di essere lui il protagonista, il deus ex machina. Solo che non gli sta dietro nessuno, perché le idee non sono ancora troppo a fuoco, hanno bisogno di essere incanalate nel percorso giusto; perché armeggia senza troppa dimestichezza con i primi synth cui era riuscito a mettere le mani sopra, mentre gli eighties stavano finendo e il rock stava prendendo altre direzioni; perché, soprattutto, era già allora il dittatore di se stesso, della sua arte, uno che prima di dare ascolto a qualcun altro sarebbero dovuti passare dei decenni (poi quel qualcuno è arrivato e risponde al nome di Atticus Ross, ma è tutta un’altra storia).
Quindi fin da subito i Nine Inch Nails sono Trent Reznor e viceversa, solo una sigla dietro cui celare brani scritti da solo, suonati da solo, registrati da solo, portati davanti a momentanei e traballanti “compagni di band” solo a cose fatte e con ben poche chance di apportarvi una qualche modifica o aggiunta. Anticipato dal singolo Down In It, primo brano mai scritto da Reznor cui non a caso viene assegnato il ruolo di apripista, il 20 Ottobre del 1989 esce Pretty Hate Machine su TVT Records, unica etichetta indipendente che aveva acconsentito alle pretese di controllo totale avanzate da Reznor.
Il disco è una bomba che esplode letteralmente nella mani di Reznor e della label, una bomba che trova il suo materiale infiammabile nella frustrazione del suo creatore, alle prese con la costruzione di se stesso prima che dei suoi pezzi, schifato da gran parte di ciò che vede quotidianamente attorno a sé, deluso dagli altri esseri umani e da se stesso, annegato in una insicurezza che non l’ha vinta solo perché meno forte della sopraccitata ambizione. Fan degli Skinny Puppy (per i quali aveva aperto qualche concerto), ammiratore dei Ministry e affascinato osservatore del lavoro dei Depeche Mode, Reznor innesca nel cupo industrial elettronico del disco gli elementi pop che ne decreteranno il successo.
È il caso di Sin, arrembante cavalcata sintetica con un refrain ai confini del catchy, ma soprattutto di Head Like A Hole, traccia d’apertura scritta da Reznor in pochi minuti per chiudere il disco e diventata ciononostante uno degli highlights dei NIN, un’invocazione di Reznor al dio denaro come rappresentazione del successo, un dio per il quale è disposto a fare di tutto, a sacrificare tutto. La potenza prettamente metal nascosta dietro strati di synth di Terrible Lie è un altro dei segreti del successo dell’album, che soddisfa trasversalmente i diversi palati di gran parte del pubblico alternative, che ritrova nella musica dei Nine Inch Nails un linguaggio familiare ma al tempo stesso nuovo. E poi Sanctified, in cui Reznor campiona una marea di altra roba pescata in giro, oppure Kinda I Want To, tracce in cui a suonare sembra esserci una band vera con degli strumenti veri, mentre sono solo i synth a sovrapporsi inscindibilmente l’uno sull’altro.
L’unica ballata, per così dire, di “Pretty Hate Machine” arriva esattamente a metà disco ed è un vero e proprio manifesto del Reznor-pensiero: Something I Can Never Have, infatti, dietro l’apparente devastazione per una donna persa che Reznor sa di non poter mai più avere, nasconde tutta la rabbia accecante, la frustrazione per obiettivi che stanno lì a pochi passi ma per i quali nessuna rincorsa, nessuno slancio sembra essere sufficiente a raggiungerli. In più, è la traccia che più delle altre segnerà quello che saranno da qui in poi i Nine Inch Nails, oscura e drammaticamente intima, struggente nella sua crudezza.
Lontano dall’essere un lavoro perfetto (Trent ad esempio non sapeva ancora come usare al meglio le sfumature della propria voce, né come incastrare tra loro strumentazione classica e sintetizzatori), sicuramente non paragonabile per perizia compositiva a ciò che Reznor avrà in serbo per il futuro dei Nine Inch Nails, “Pretty Hate Machine” ha il merito di stappare la frizzantissima e amara magnum di un vero e proprio genio, lanciando in un’orbita mainstream quell’industrial rimasto fino a quel momento appannaggio dell’underground e aprendo il viatico a una delle esperienze più significative degli interi anni ’90 (e oltre).