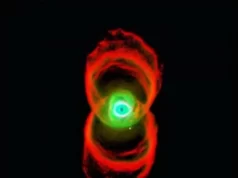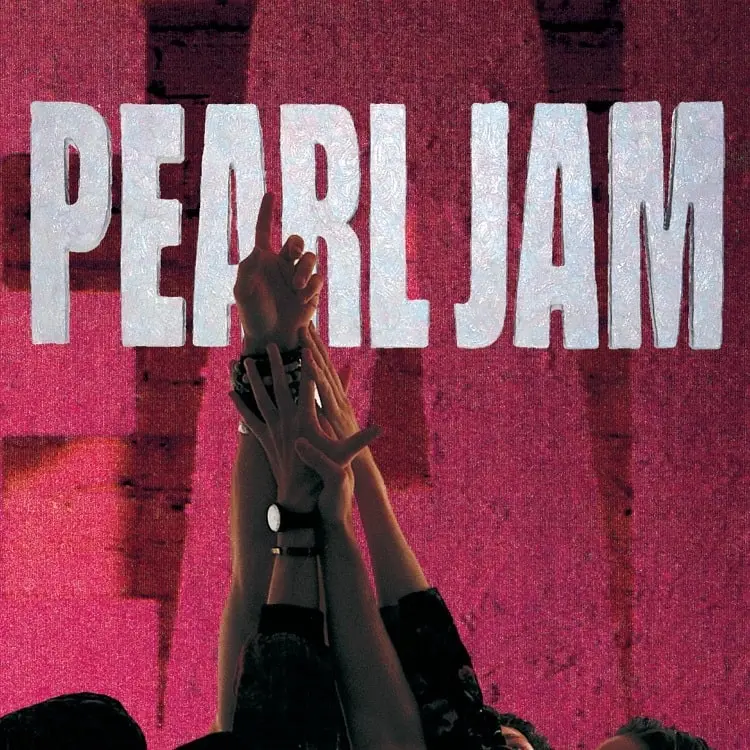
A pensarci bene, i Pearl Jam non sono nati che per reazione. Sì, reazione a un lutto, a un sogno infranto, al destino beffardo che aveva bruciato le ali con cui Andy Wood stava per spiccare il volo e con lui i Mother Love Bone. Stone Gossard e Jeff Ament avevano trovato in Wood il frontman perfetto per la loro idea di rock glitterato e tendente agli eccessi eighties che cercavano da un po’ di concretizzare, e quando l’eroina si porta via Andy, il 19 Marzo del 1990, crolla un castello di carte costruito con fatica. Una botta pazzesca per Gossard e Ament, certo, ma anche per Chris Cornell, amico fraterno di Wood, e per l’intera scena di Seattle, sul punto di esplodere proprio grazie a questa cricca di musicisti. Se lo sentivano tutti che stava per accadere qualcosa di importante e sapevano tutti che Andy era uno dei cardini di quel qualcosa.
Prima dei Pearl Jam, però, c’era stata un’altra reazione alla perdita di Andy: i Temple Of The Dog. Cornell, Gossard e Ament, i più colpiti dalla tragica fine di Wood, hanno in mente un tributo all’amico. Sul finire di quell’anno nefasto chiamano con loro Mike McCready, che già da qualche tempo aveva iniziato a suonare insieme ai due ormai ex Mother Love Bone, e Matt Cameron, che faceva già sfracelli dietro le pelli dei Soundgarden. La visceralità di quelle registrazioni, i testi di Cornell, segneranno uno dei passaggi fondamentali dell’intero fenomeno grunge. Ma il nodo centrale di quel disco è “Hunger Strike”, un pezzo che Cornell non riesce subito a finalizzare, finché in studio di registrazione non fa capolino un ragazzo in città da poco e da poco impegnato a fare qualcosa insieme a Gossard, Ament e il loro nuovo progetto di band. Vedder canta le parti sui cui Cornell si trova in difficoltà, tra i due nasce lì un’amicizia speciale ed è lì che Gossard e Ament si rendono definitivamente conto di aver trovato la persona giusta.
Persona giusta per cosa? Per i Mookie Blaylock, primo nome di quel nuovo progetto per il quale Vedder s’era spostato da San Diego a Seattle dopo aver cantato sopra a qualche demo su suggerimento dell’amico comune Jack Irons, batterista dei Red Hot Chili Peppers (e in seguito anche degli stessi Pearl Jam). I Mookie Blaylock diventeranno in breve i Pearl Jam e in brevissimo Vedder avrà anche i testi delle undici tracce che la band andrà a incidere al London Bridge Studio. Eddie quasi ci vive dentro quegli studi, non possiede ancora il mestiere del songwriter e il flusso di coscienza che l’accompagna insieme a carta e penna va incanalato nella direzione giusta, con il massimo della concentrazione possibile. Ed è così che a cavallo tra Marzo e Aprile del ’91, proprio mentre l’omonimo disco dei Temple Of The Dog arriva nei negozi di dischi, prende forma Ten, l’esordio dei Pearl Jam.
“Ten” è un diamante che cristallizza la poetica ancora acerba ma già dannatamente profonda di un Vedder che va avanti e indietro nel suo passato e nel presente americano, con i primi ma pesanti cenni politici dei Pearl Jam: Jeremy si ispira tutt’altro che velatamente al suicidio del sedicenne Jeremy Wade Delle, sparatosi in bocca davanti ai compagni di classe a inizio ’91 (il videoclip del pezzo, censurato, contribuirà enormemente al successo di “Ten”); Even Flow ha il punto di vista di uno delle migliaia di homeless che si possono incontrare per le strade delle metropoli americane; in Once fanno nuovamente comparsa le armi e la malattia mentale di un uomo che diventa serial killer; Why Go racconta di una ragazza che, sorpresa a fumare erba, viene rinchiusa dai genitori in una clinica di riabilitazione, mentre in Deep è la violenza sessuale ad affliggere ancora un’altra ragazza.
Ma è il Vedder più intimo a segnare in modo più incisivo “Ten”: Black è una canzone d’amore e abbandono da pelle d’oca, così personale da convincere Eddie e la band a non sfruttarla come singolo, nonostante le insistenze della casa discografica che aveva fiutato il colpaccio; Alive è inno per definizione, con Vedder che snocciola per gran parte del pezzo la storia di un uomo (se stesso) “ancora vivo” nonostante la lacerante scoperta che quello che credeva fosse suo padre in realtà era il patrigno; Oceans è un omaggio di Eddie al mare come luogo di riconciliazione dell’uomo con la natura (oltre che alla sua passione per il surf, praticato in California), onde che ritornano anche nella conclusiva e catartica Release.
Il contraltare dei testi di Vedder sono senza dubbio le chitarre di Stone Gossard e Mike McCready: i riff ragionati del primo e gli assolo marcatamente seventies del secondo fanno il buono ed il buonissimo tempo di “Ten”, con Alive che si erge una spanna sopra le altre per impatto anthemico. Il minimo comune multiplo del grunge si sente forte anche nell’esordio dei Pearl Jam, con il tocco punkeggiante di Porch e il piglio hard rock di Once ed Even Flow, mentre vanno a cercare qualcosa di diverso la psichedelia appena accennata di Garden e il bluesaccio di Why Go (in cui Jeff Ament dà sfogo alle sue influenze funk). Il tutto riunito sotto la produzione piuttosto edulcorata di Rick Parashar, che aveva già prodotto i Temple Of The Dog e che l’anno seguente si sarebbe occupato anche del singolone “Would?” degli Alice In Chains.
Uscito meno di un mese prima di “Nevermind”, il secondo fondamentale album dei Nirvana, “Ten” condividerà col coevo disco della band di Kurt Cobain il ruolo di traino definitivo del grunge, due lavori parecchio diversi fra loro accomunati da quello sbocco mainstream che sarebbe servito alla scena di Seattle per uscire definitivamente dalla dimensione alternative e puntare in alto, alle classifiche di tutto il mondo, ai contratti milionari con le major, alle arene, a quella che sarebbe stata vera e propria leggenda.