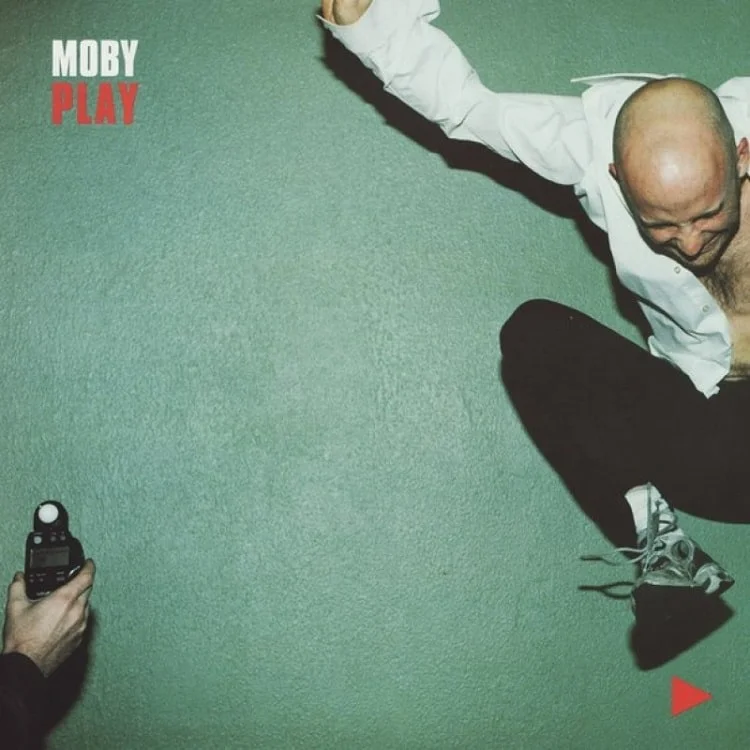
È il Febbraio del 2000 e Richard Melville Hall, già conosciuto come Moby, si trova in Minnesota quando riceve la telefonata del manager Eric Härle che gli comunica sorprendentemente la prima posizione di Play nelle classifiche inglesi: aveva scalzato dal podio “Supernatural” di Santana. Niente di strano, fino a qui, se non fossero passati dieci mesi dalla distribuzione del disco sul mercato mondiale. Casualità? Non proprio. Nonostante Hall abbia già all’attivo quattro album discreti, nel 1999 sta ancora scontando la condanna derivata dall’insuccesso di “Animal Rights” (1996), reo di averlo macchiato di un’incoerenza stilistica difficile da interpretare. I rapporti con l’Elektra Records si erano interrotti bruscamente, nel 1997 durante il tour di quel devastante fallimento. Non è neanche bello, Hall, non buca lo schermo e se non ci riesci nell’era in cui MTV detiene il monopolio nella distribuzione della tua immagine sei fottuto. Tra il 1998 e il 1999, ispirato da “Sound Of South”, una delle raccolte che includevano i field recording effettuati dall’etnomusicologo Alan Lomax, Moby mette in scena quello che pensa essere l’atto ultimo della sua carriera.
A fare da spartiacque tra un prima e un dopo “Play”, facendo esplodere l’ordigno che condurrà l’album a vendere oltre dodici milioni di copie in tutto il mondo, saranno tre fattori fondamentali: il rifiuto delle radio statunitensi a trasmettere l’album, l’istinto di sopravvivenza dell’artista newyorkese che lo porta a rilasciare le licenze di utilizzo alle agenzie pubblicitarie per le tutte le tracce dell’album e l’inclusione di Porcelain nella OST di “The Beach” (protagonista quel giovane Di Caprio che di fascino ne aveva fin troppo).Il successo di “Play” è più che meritato, uno dei primi album a cavallo tra vecchio e nuovo millennio che porta con sé l’innata capacità di sperimentare dell’artista statunitense: una mistura quasi perfetta tra ambient, elettronica, house, techno, blues e spiritual.
Quasi, si è detto, perché alcune “sviste”, relative al copyright delle tracce campionate, perlopiù canti della tradizione gospel e spiritual afroamericani e pezzi hip hop, macchiarono senza troppo clamore un disco che per genialità e raffinatezza non meritava alcuna ombra.Su diciotto tracce quasi la metà nascono dal geniale saccheggiamento di uno tra gli artisti più eclettici dell’era moderna (la traccia vocale di Honey è tratta da “Sometimes” di Bessie Jones, mentre il piano da “Woman To Woman” di Joe Cocker, Find My Baby da “Joe Lee’s Rock” di Boy Blue, Bodyrock da “Love Rap” dei Spoonie Gee & The Treacherous Three, Natural Blues da “Troubled So Hard” di Vera Hall, Run On da “Run On For A Long Time” di Bill Landford & The Landfordaires, Machete contiene la drum machine di “Apache” degli Incredible Bongo Band, The Sky Is Broken riprende la batteria di “Long As I Can See The Light” dei Creedence Clearwater Revival).
E sebbene non sia stato posto nessun problema in ordine alle regolari richieste di utilizzo dei pezzi e il booklet abbondi di fonti e ringraziamenti per tutti gli autori originali e per il lavoro dei Lomax, nelle prime tirature di “Play” stranamente non apparve alcun riferimento a Vera Hall, autrice di quella “Trouble So Hard”: considerata la sacralità sia del soggetto campionato che del campionatore (Natural Blues fu peraltro il successo più deflagrante dell’album), si trattò di una piccola caduta di stile che a tutt’oggi può far storcere il naso.Ma se da un lato “Play” si trascina dietro lo spettro di un uso del sampling non unanimemente condiviso, riportando alla luce la questione del mancato riconoscimento dei diritti ad autori fortemente discriminati, ha il grande merito di rivestire con una complessità del tutto nuova documenti, artisti e composizioni dal valore inestimabile che altrimenti sarebbero stati relegati negli archivi polverosi della Lomax.
Il successo di “Play” e la sua costante rotazione su spot, film e radio fu in grado di stuzzicare l’appetito di una marea di artisti a riutilizzare piccole meraviglie pressoché sconosciute, con i The Black Keys che ricampionarono Vera Hall nella loro “Stack Shot Billy” o Eminem che per la sua “My Name Is” prese in prestito “I Got The…” di Labi Siffre. Non solo: “Play” è frutto di uno splendido sforzo pionieristico, una nuova veste di muzak, la lucentezza chill out di Porcelain, il piano fluttuante di Rushing, i synth spumosi di Down Flow, il minimalismo di The Sky Is Broken, la spettralità di My Weakness. Fu l’album che cristallizzò il successo discografico di Moby, techno monk, così fu ribattezzato, l’album che mostrò al mondo per la prima e ultima volta le due anime della musica elettronica: una sacra come il vangelo, l’altra spietata come la techno.

